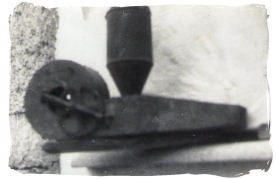|
PARTE TERZA
Folklore economico ed ergologico
Una panoramica degli usi e dei costumi della popolazione di Isolabona non può in alcun modo diversificarsi profondamente dagli usi e dai costumi che in passato erano peculiari delle popolazioni della Val Nervia e delle valli limitrofe, per cui, volendo restringere il campo e prendere in esame unicamente il paese di Isolabona è opportuno limitarsi all’esame di quei soli elementi di cui ancora permane una eco nei ricordi dei più anziani, avendo i giovani tagliato ormai quasi totalmente le radici. E pertanto, nell’illustrare usi e tradizioni ormai scomparse o in via d’estinzione, relativi al folklore economico (caccia, pesca, pastorizia, abitazioni, agricoltura ecc.), a quello familiare-sociale e a quello religioso, si farà riferimento solo ai "ricordi degli isolesi", raccolti durante una ricerca sul territorio effettuata alcuni decenni or sono.
La caccia
La res cinegetica, fin dai tempi più remoti, è sempre rimasta una attività incontrastata in mano agli uomini. Ancora qualche decennio fa, prima che leggi severe intervenissero a regolamentare la caccia, nel giorno di apertura della stessa si poteva assistere ad una totale dispersione dei cacciatori, esperti e pivelli, per le colline ricoperte di ulivi, per i boschi e le pendici brulle e aride delle Prealpi. Tralasceremo di parlare della vera res cinegetica,quella effettuata con l'ausilio dei cani, per trattare invece di quei pochi sistemi usati dai valligiani per insidiare la fauna della valle, un tempo assai ricca. Le tracce di sistemi particolari, di cui ancor oggi si serba la memoria, sono per lo più legate alla cacciagione dei pennuti quali gli uccelli di passo (storni, colombi, tortorelle, anitre, quaglie regine, beccacce, beccaccini, tordi, merli...) e alla selvaggina stanziale (fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, starna...). Si può ritenere che una delle forme più comuni di uccellagione sia sempre stata quella effettuata col vischio, una sostanza collosa estratta dalle bacche del Viscum album, utilizzando come richiamo una civetta, sistema cui fa cenno il Machiavelli in una sua opera. Il metodo era semplice: si poneva una civetta in uno spazio libero, contornato da bassi cespugli e su di essi si stendevano le panie (fili d'erba ricoperti di vischio). Gli uccelli, probabilmente attratti dagli occhi gialli della civetta, si avvicinavano, si posavano sui rami dove rimanevano con le piume attaccate alle panie. Una variante fu quella di sostituire la civetta con una gabbia contenente uccelli da richiamo. In tal caso venivano usate panie più grosse (panioni) posti tutti attorno alla gabbia. Altro sistema era quello di stendere le panie in prossimità delle pozze d'acqua, dove gli uccelli si recano per bere o per lavarsi, oppure porre vergelle invischiate lungo i ruscelli, limitando lo spazio libero attorno ad esse con sterpi per costringere i pennuti a posarsi là dove era stata posta l'insidia. L'uso delle ciapure, speciali trappole che permettevano di catturare l'animale vivo, è scomparso. Le ciapure consistevano in una lastra, normalmente d'ardesia, che veniva collocata in bilico, mediante un ingegnoso sistema di stecchetti, sopra una buca scavata nel terreno. Dentro la buca veniva posto il mangime su un'assicella collegata agli stecchi che sostenevano il peso della lastra d'ardesia. Il peso dell'animale faceva scattare la trappola e la lastra, cadendo, imprigionava la preda. Altro sistema fu quello costituito da rami verdi, flessibilissimi, generalmente di nocciolo, che venivano piegati a ferro di cavallo. Le due estremità erano tenute in tensione da un filo sporgente a cappio, trattenuto da un bastoncino mobile su cui era posta l'esca. Il malcapitato uccello, posandosi sul bastoncino per beccare l'esca, lo faceva cadere e il ramo, riprendendo la sua primitiva posizione lineare, stringeva la preda nel cappio. Le ciapure cui abbiamo accennato servivano per catturare anche conigli e lepri. Per questi animali si usarono pure trappole a laccio costituite da cordicelle fatte con crini di cavallo terminanti con un nodo scorsoio. Venivano poste lungo dei percorsi obbligati, costruiti con frasche opportunamente disposte. La morte della preda avveniva per strozzatura. In disuso sono pure le peighe, oggi usate solo per catturare topi. Si tratta di trappole metalliche a torsione, composte da due semicerchi di ferro, tenuti assieme da una molla d'acciaio. I due semicerchi venivano aperti e tenuti tesi per mezzo di un braccio mobile attaccato al quale era posta l'esca. L'uccello, beccandola, spezzava l'equilibrio e la molla, scattando violentemente, costringeva i due semicerchi a chiudersi, strozzando in tal modo l'uccello.
La pesca
Non si può certo parlare di grande pesca lungo i due torrenti Nervia e Merdanzo perché la varietà e la quantità di pesci è sempre limitata. Un tempo, però, non era raro vedere pescatori con la canna in mano, rimanere immobili per ore, in attesa di qualche buona preda. La pesca, quindi, era da considerarsi un passatempo e raramente come fonte di sostentamento. Lo testimonia un proverbio (noto peraltro in tutta la Liguria) che recita: "Pescauu de cänä, cacciauu de viscu, purtauu de Cristu, i sun i trei ciü belinui che gh’a sciu sta tara”. (Pescatore con canna, cacciatore con vischio, portatore di Cristo [durante le processioni religiose] sono i più fessi che esistano sulla faccia della terra) sistemi di pesca del passato furono: u massäme; e fascine; a mässä; u väregu; a cucura; e secägne. La pesca col massäme è assai caratteristica e serve esclusivamente a catturare anguille. Il massame è composto da una canna rigida della lunghezza di circa due metri e mezzo, tre metri con un filo legato ad una estremità e avente la lunghezza della canna. All'estremità opposta del filo veniva legato un piombo e un mazzetto di lombrichi. L'abilità del pescatore consisteva nel confezionare il mazzetto dei lombrichi che funzionava da esca. Questo era composto un discreto numero di vermi di terra, attraversati uno per uno, per tutta la loro lunghezza, da un filo resistente. Dopo aver ottenuto una "collana di vermi" lunga un metro, la si avvolgeva sulla mano in modo da farne un insieme unico della grossezza di un pugno. Era questo il massame che veniva legato unitamente al piombo. La pesca richiedeva anche l'uso di un ombrello. Dopo aver intorbidato l'acqua di un laghetto o dopo che la pioggia aveva ingrossato le acque, intorbidandole col fango strappato dalle rive, il pescatore gettava l'esca e attendeva che l'anguilla abboccasse. Quando mordeva e, di conseguenza, rimaneva con i dentini anteriori impigliata nel filo che teneva "cuciti" i vermi, il pescatore tirava lentamente e, pronto con l'ombrello tenuto aperto e rovesciato nell'altra mano, non appena vedeva l'animale a fior d'acqua, dava uno strappo e cercava di far cadere il massame con l'anguilla attaccata dentro l'ombrello. La forma concava di questo impediva all'anguilla di scappare. Altra pesca all'anguilla si effettuava con le fascine. Si trattava di semplici fascine di rami, strettamente legati, poste nei laghetti. Venivano gettate di sera e ritirate al mattino successivo. Nei periodi caldi le anguille, forse per liberarsi dal muco che le ricopre, entravano nelle fascine e vi rimanevano, Le fascine venivano lentamente tirate a riva e aperte. Per poter afferrare il lungo e viscido animale si utilizzava un paio di speciali forbici, lunghe cinquanta centimetri, le quali avevano al posto della parte tagliente una parte seghettata che permetteva di trattenere l'anguilla senza tagliarla in due. La pesca con la mässä consisteva nel colpire violentemente e ripetutamente con una mazza di ferro i massi erratici che affioravano in mezzo alla corrente, sotto i quali si rifugiavano pesci e anche anguille. Questi venivano poi rovesciati a mano o con l'aiuto del parfaru (palanchino). I pesci, rimasti storditi e incapaci di mettersi in salvo, erano catturati. Esisteva pure una pesca assai proficua a carattere collettivo, non tanto per il lavoro che occorreva per metterla in atto, quanto per la quantità di pesci e anguille che procurava. È la pesca col väregu. Il väregu è un succo denso e lattiginoso, estratto da una pianta comune nella valle, in particolar modo nei dintorni di Camporosso: l'Euphorbia Amygdaloides. Dopo aver raccolto una discreta quantità di radici di tale pianta, si pestavano ben bene e si ponevano poi a macerare o sotto terra o sotto il letame. A tempo opportuno, cioè con la luna vecchia, si mettevano le radici macerate dentro sacchi di iuta e si portavano nella località scelta per la pesca; si ponevano lungo il filo della corrente e poi si cominciava a pestarli con i piedi. Il succo biancastro che ne fuoriusciva si spandeva per lungo tratto, da una riva all'altra, stordendo tutti i pesci e le anguille. Al posto del veleno naturale, per piccoli laghetti o pozze d'acqua, venivano utilizzati veleni chimici, come l'estratto di nicotina, oppure la calce viva. Un metodo di pesca all'anguilla era quello in cui si usava la cucura, un veleno vegetale. Purtroppo, essendo tale metodo proibito dalle vigenti leggi, esso è ormai scomparso anche tra i pescatori di frodo, per cui, pur essendosi tramandati gli effetti che produceva, c’è incertezza sulla pianta da cui si ricavava la sostanza velenosa. Alcuni affermano si trattasse di una bacca (senza riuscire a precisare la pianta) altri da una specie di fungo. Di quest’ultimo si è trovata notizia. Sembra che si tratti del fungo del genere dei basidiomiceti, il Coprinus comatus, il quale, pur mangereccio, può produrre una sostanza particolare se posto a contatto con l'alcool. Per produrre l'esca occorreva una accurata e lunga preparazione. Si prendevano dei lombrichi, si tagliavano a pezzi e si mettevano a seccare al sole. In un barattolo si metteva uno strato di funghi poi uno strato di vermi secchi e così via fino al riempimento del barattolo. A questo punto si versava nel barattolo uno o due bicchieri di grappa e si lasciava il tutto a macerare per qualche giorno. Il verme a poco a poco da secco che era, assorbendo alcool e con esso il veleno che l’alcool stesso aveva ‘distillato’, diventava turgido e pronto ad essere usato. Bastava lanciarne una manciata in qualche laghetto ed aspettare. L’anguilla, ghiotta di vermi, addentando qualche pezzo, rimaneva letteralmente folgorata. Sembra, infatti, che il veleno paralizzi istantaneamente i centri natatori e agisca sull'apparato respiratorio dell'animale. Questo, in realtà, non inghiottiva il boccone, anzi cercava di risputarlo e succedeva così che con un solo boccone si prendessero più anguille. Il metodo è proficuo solo se le anguille abboccano subito in quanto l'esca, lasciata a lungo nell'acqua, perde il suo potere. In passato si potevano vedere lungo il torrente luci vaganti. Si trattava di pescatori che usavano il sistema delle freijale. Si tratta di una minivariante della pesca che in mare si fa con le lampare e che si basa sul fatto che, esposti una forte sorgente luminosa, i pesci rimangono immobili. Quale sorgente luminosa nel passato remoto si usavano rami resinosi di pino; in tempi più recenti venivano usate lampade ad acetilene. Per catturare le prede si adoperava un salaio o un barancin (retino o bilancia a rete). Talvolta veniva utilizzato il metodo della seccägnä che consisteva nell'arginare e deviare la corrente in modo da lasciare all'asciutto una parte del torrente. Pesci e anguille rimasti intrappolati venivano catturati con le mani, con le forbici su citate o facendo uso di una forchetta per infilzare le anguille.
La pastorizia
Un tempo, unitamente all'agricoltura, costituiva la fonte primaria sostentamento. Ne è testimonianza la costante presenza nei documenti notarili di clausole inerenti la pastorizia e i luoghi da adibirsi a pascolo, fonte di perenni contese fra i paesi della valle. Il Rossi, nella Storia del Marchesato di Dolceacqua, cita, ad esempio, un passo di uno Statuto del 1267 in cui il legislatore così divideva alcuni territori dei comuni di Baiardo, Isolabona e Apricale: "coherencie sunt iste: primum podium Abrigi et descendit per vallonum Abrigi et vadit per passum Gallinayra colligendo totam Canavairam et ferit usque ad terram Bayardi. Item a Collecta Bassa Marcole descendendo per vallonum usque ad aquam Bunde et a dicta Macole usque ad territorium Bayardi.” Oggi, tranne qualche gregge che ancora pascola lungo le pendici del monte Toraggio, la pastorizia è scomparsa. Una scomparsa recente perchè durante il periodo dell'ultima guerra non era raro vedere greggi pascolare lungo i torrenti o fra gli uliveti. Si trattava per lo più di animali di proprietà di varie famiglie, allevati sia per stallatico sia per la produzione del latte, allora assai scarso. In passato, all’arrivo della stagione del pascolo, i pastori salivano a S.Giovanni verso i verdi pascoli dove vivevano all’aperto o trovavano rifugio in grotte o malghe. La produzione casearia cui si dedicavano consisteva nella produzione di piccole forme di formaggio pecorino chiamate tumete e nel fornire ai consumatori del fondovalle il cosiddetto brussu, una pasta densa e piccante, ottenuta dalla fermentazione del latte cui era stato aggiunto caglio, sale, pepe e acquavite. Un alimento ancor oggi presente sulle mense locali. Il suo consumo fu così alto in passato da dare persino il titolo ad una commedia in dialetto ventimigliese: "L'amuu u l'è ciù forte du brussu" (L’amore è più forte del brussu)
Il modo di vestire dei pastori era molto semplice. Gli abiti erano confezionati con canapa e con lana cardata mediante un rudimentale pettine formato da un pezzo di legno quadrato su cui erano infissi dei chiodi sporgenti. La lana veniva poi filata e tessuta ottenendo una stoffa chiamata stamegna, tanto spessa da essere quasi impermeabile. Per cappello usavano un casco di lana grezza di color rosso. I calzoni, di color marrone, erano trattenuti in vita da una cintura di cotone, generalmente rossa, assai lunga tanto da fare alcuni giri attorno alla vita. Erano corti e abbottonati sotto le ginocchia; le gambe venivano avvolte in rozze fasce di lana grezza, Per calzature usavano scarponi da montagna. D’inverno indossavano un ampio tabarro chiamato u gunèè. Sulle spalle portavano una bisaccia dove riponevano il cibo. Alle due estremità della bisaccia era legata una cinghia che era messa a tracolla e lasciava libero l’uso delle mani. Un bastone, a volte intagliato, completava il quadro. Le donne portavano sottane di panno rosso, guarnite in fondo da strisce ricamate o in velluto nero. Sul corpo una pettorina pure essa rossa sovrapposta ad un corpetto nero. Sulle spalle un ampio scialle con frange. I capelli erano per lo più riuniti in una lunga treccia e poi avvolti a chignon dietro la testa.
Le abitazioni
Isolabona, come molti altri borghi della valle, si presenta come un agglomerato di case organizzate a difesa reciproca ed ha una semplicità primitiva. Sorse alla base di una collina nel punto in cui si congiungono i due torrenti Nervia e Merdanzo. Nella parte superiore i Doria costruirono il castello, mentre i lati del paese, a nord e a sud, erano formati dai muri massicci delle abitazioni, costruite senza interruzione di continuità, e nei quali non vi era alcuna apertura di sotto ai dieci metri. Le uniche due vie d’accesso al paese erano difese a est dal Castello e ad ovest da uno sperone roccioso, sotto il quale scorre il Nervia, collegato all'altra sponda da un ponte a schiena d'asino (distrutto nell'ultima guerra e poi ricostruito). Il paese racchiuso in questa cinta muraria, rimasto immutato nel tempo, presenta un brulichìo di rampe, di saliscendi, di stretti carruggi le cui opposte facciate delle case sono a volte unite da archetti in muratura, con funzione antisismica, a volte da una vera e propria grotta su cui è costruita un’altra abitazione. Era il bisogno di difesa che faceva sorgere simili costruzioni. Del Castello, una costruzione a se stante, sono rimaste solo le mura perimetrali, le quali non permettono di capire quale potesse essere l'architettura interna ( sembra che il castello non sia mai stato completato). Per coloro che volessero farsene una idea, si rimanda alla accurata descrizione che lo storiografo G. Rossi ci ha fornito del Castello dei Doria di Dolceacqua. Le case del nucleo storico Isolabona si presentano quasi tutte strutturate in un modo particolare. Normalmente la casa da abitazione è composta da 4/5 vani, quasi sempre sovrapposti su 2/3 piani. E' costruita in pietra e calce, con spessi muri perimetrali (50/70 cm e anche più). I soffitti sono a volta. Le finestre sono piuttosto piccole e non rispettano quasi mai una regolare simmetria edilizia esterna. Al piano terra si trovano uno o più locali adibiti a stalla o deposito per foraggi, prodotti della terra e attrezzi agricoli oppure a cantina. Le porte, non sempre munite di serratura, venivano un tempo chiuse dalla tartavala, un piolo di legno dentellato, situato orizzontalmente dietro la porta, a mezza altezza, che veniva azionato dall'esterno per mezzo di un ferro uncinato. Si accede al primo piano mediante una scala in muratura, con scalini in ardesia. La prima rampa è quasi sempre esterna e un piccolo ballatoio forma l'ingresso della casa. Il vuoto formato sotto la scala esterna e sotto il ballatoio dava origine ad un minuscolo vano chiamato stagetu, destinato al deposito di legna o attrezzi. La cucina era generalmente al primo piano e in un muro perimetrale stava il camino dal quale pendeva una catena per agganciare marmitte, padelloni, in particolar modo quelli per cuocere le castagne. Di fronte ad esso stava un banco in muratura su cui era appoggiata la seglia (secchia per l'acqua) e in cui era ricavato un pozzetto per la lavatura quotidiana delle stoviglie. In un angolo, bene in vista, stava u bancää, un mobile a metà fra la cassapanca e la madia. In ogni cucina non mancavano mai i lumi a olio di caratteristica fattura, le lucerne, le batterie di rame, il mortaio ecc. Tra gli strumenti del buon tempo antico è da notare vicino agli alari u sciüscietu, il soffietto, formato da un lungo tubo di ferro in cui si soffiava per alimentare le braci. Le stanze superiori avevano un aspetto comune: letti di legno con sacconi pieni di foglie di granoturco, seggiole impagliate, un lume con a fianco esca e acciarino, a banchetta (sgabello). In certe camere, sopra il letto, venivano poste della canne a forma di pergolato le quali servivano per sostenere grappoli d'uva cui si lasciava un lungo tralcio per appenderli, mele e pere legate per il picciolo, tutta frutta da consumare nei mesi invernali. Il solaio serviva quale deposito per la legna, per patate, per le castagne. Il tetto era ricoperto da coppi o tegole o lastroni di pietra disposti a embrice.
Per le campagne oltre ai terüssi di cui già si è detto, vi erano pure i casui (metati) che tra l’altro servivano per l’essiccazione delle castagne. Erano costituiti da quattro muri perimetrali alzati a secco, con due finestre, una porta e il tetto senza soffitto. Il pavimento era in terra battuta. Servivano per riparo e anche per deposito di concime. Uno dei pochi mobili presenti era il boregu, consistente in una sezione di un tronco d'albero, alta dai 60 ai 70 centimetri, nella cui parte superiore veniva praticato un incavo profondo 30/40 cm. Serviva per depositarvi il cibo. Sull'incavo veniva posta una lastra d'ardesia che fungeva da coperchio e al tempo stesso da desco.
L'agricoltura
Considerando la
valle nel suo complesso, si può suddividerla in tre distinte zone: la
floreale che va dalla riva del mare Per quanto concerne l'industria vinicola, i metodi non sono molto mutati rispetto al passato. Ancora oggi per la raccolta e il trasporto a valle su utilizzano i curbin e le curnüe. I primi consistono in gerle fatte con sottili lamelle di legno di castagno intrecciate a forma di parallelepipedo e vengono trasportate trasversalmente sulle spalle o poste in coppia ai lati del basto di un mulo. Una volta pieno, la parte aperta del curbin viene chiusa da un telo quadrato di iuta, u curau, che ha ad ogni angolo una fettuccia di circa 70 centimetri. La forma del curbin, alto un metro circa, è motivata forse dagli stretti sentieri e mulattiere che uomini e animali devono percorrere e, inoltre, rende facile il trasporto in quanto viene portato trasversalmente sulle spalle, appoggiato su un sacco rigonfio d'erba e piegato in modo da formare un cappuccio che ricopre la testa. Lo strano appoggio viene chiamato pagliassu.
Altri attrezzi curiosi legati alla produzione del vino erano a cupa du vin, che veniva usata a mo' di mestolo per attingere vino da un tino o da una botte. La si ricavava da una speciale zucca (Lagenaria vulgaris) che cresce a forma di fiasco con un lunghissimo collo. Una volta essiccata poteva essere usata in duplice modo. Vuotata dei semi dalla parte del collo aveva la funzione di conservare un liquido (in questo caso è nota anche col nome di 'zucca del pellegrino', (quasi sempre presente nell’iconografia dedicata a S.Rocco). Se, invece, si praticava una apertura nella parte panciuta, la si poteva usare come un mestolo. Oltre a cupa du vin veniva anche chiamata a ciuca da marda, (la zucca per il liquame) se si usava per vuotare i pozzi neri. Altro attrezzo è l'apusauu, o pigiatore. Consiste in un lungo ramo d'albero, avente ad una estremità il moncone di tre, quattro rami divergenti. Serviva durante la fermentazione dei raspi pigiati per spingerli verso il fondo della botte, dato che essi tendono sempre a risalire in superficie.
Per la produzione
dell'olio alcuni metodi risalenti al passato hanno subito variazioni.
Durante il periodo della raccolta dei Quando ancora non esistevano gli asili, non era raro vedere appeso ai rami di un ulivo, a mo' di amaca, un curauu dentro il quale veniva posto qualche bimbetto strettamente avvolto in fasce affinché non cadesse o sfuggisse alla sorveglianza o, credenza popolare assai diffusa, non si addormentasse e rimanesse in balìa di qualche serpentello pronto ad introdursi nella sua bocca per succhiargli il latte precedentemente preso. Sebbene robusti, i bimbi non avevano la forza di Ercole per poterlo strozzare! L'abbacchiatura avveniva e avviene ancor oggi mediante l'uso di lunghe pertiche flessibili e ramauire. Un tempo, quando non era in uso la rete di nylon, solo al momento dell'aramä, dell'abbacchiatura, si stendevano a terra larghi drappi bianchi, le tende, su cui cadevano frutti, foglie e rametti che la lunga pertica strappava all'albero, per cui occorreva, a fine giornata, separare i frutti da tutto il resto.
Un sistema più
recente è l'uso della "chitarra". Si tratta di una specie
di scivolo delle dimensioni di 70x200 centimetri, composto da una
serie di fili posti secondo la lunghezza ed equidistanti gli uni
dagli altri quel tanto da non lasciar filtrare i frutti ma solo le
foglie. Sulla "chitarra", posta inclinata, venivano
fatte scivolare foglie e olive; queste ultime rotolavano velocemente e si
accumulavano in basso, mentre le foglie cadevano a metà strada.
Chi oggi percorre la strada che da Ventimiglia va a Buggio, incontra lungo il tragitto ruderi anneriti dal tempo, ricoperti d'edera, formati da un corpo principale, con a fianco delle vasche digradanti, collegato con un canale aperto. É u defisiu, (frantoio), l'edificio dove i produceva l'olio. All'interno vi sono ancora le pile entro le quali venivano frante le olive e u gumbau, la grossa macina formata da una enorme pietra a forma di ruota che, azionata dalla forza idraulica, serviva per la frangitura. Nella pila si versava una certa quantità di frutti misurati a carte. A carta, quarta o minetta, è la misura delle olive tuttora in uso. Consta di un recipiente cilindrico, attraversato da una sbarra di ferro, della capacità di un doppio decalitro. Quando la quarta è stracolma la si pareggia con un matterello, a randa, che ha la funzione di togliere u curmurume, il soprappiù. Altra misura piu piccola è u mauturää. Per formare una minetta ne occorrono circa sei e mezzo. Un tempo non molto lontano, per trasportare l'olio dal frantoio fin nelle panciute giare che ogni famiglia possedeva e custodiva in cantina a fianco delle botti e delle damigiane di vino, si metteva in otri di pelle di capra che una volta vuotate nella giara, potevano essere accuratamente strizzate per recuperare l'olio fino all'ultima goccia. Il compenso per il frantoio non era versato con una somma in denaro, ma era uso lasciare al padrone (un tempo al feudatario locale cui appartenevano tutti i frantoi) il pannello di pressatura, il fiscolo, che, opportunamente trattato, produce ancora olio, il cosiddetto öeriu lavau (olio lavato). Al frantoiano spettava pure u framegu, la sansa; di questa il produttore aveva il diritto di prelevarne una parte per suo uso e consumo,
L’ orticultura
L'orticultura viene praticata quasi esclusivamente in minuscole fasce ricavate lungo i versanti dei due torrenti o in prossimità di polle sorgive o di riane, piccoli ruscelli che scorrono tra le valli e che si immettono nei due torrenti. In questi due ultimi casi vigeva un tempo (ed oggi ne è rimasta ancora traccia) l'uso di ripartire tra i proprietari degli orti adiacenti il consumo settimanale dell'acqua. A seguito di regole verbali e scritte i vari proprietari hanno acquisito diritti che permettono loro di usufruire di un determinato numero di ore d'acqua (giornaliero o settimanale) per irrigare. Durante i periodi di siccità, quando il ruscello o la sorgente sono ridotti agli estremi, i contadini mettono in atto accorgimenti che permettono lo sfruttamento completo dell'acqua. Si costruiscono lungo il ruscello, per una lunghezza di cinquecento metri, piccole dighe in cui si formano polle d'acqua. Dopo che per continue tracimazioni le polle d'acqua sono colme, si aprono simultaneamente e si convoglia il flusso verso la zona da irrigare o meglio ancora verso qualche capace pozzo dal quale poi attingere l'acqua con comodità. Il sistema di ripartire il consumo d’acqua a ore, pur consolidatosi nel tempo, ha pur sempre generato liti tra i proprietari di orti adiacenti. Nel manoscritto Cane si leggono testimonianze di acquisto di ore di acqua o di terreni cui era legata una clausola relativa all'acqua. "1804. lì 8 Magio comprato dodeci ore di aqua al giardin da Sigr. Prevosto Cassini pagata lire cento. In tuto le registrazione scrittura sono lire 112. Fato l'istrumento Pietro Paulo Cassini". "1812... lì 3 Maggio fato estimare il pesso di fascia di mia sorela Gerolima a Gautero atiguo la nostra con parte al aqua del troglio delli trei giorni per setimana e note abiamo insieme co suo figlio Giambatista cioè la metà perun. La stimata Antonio Cascin la fascia e laqua in tuto vale settanta lire e lo pagata. “1813. li 16 Genaro hanno passato l'istrumento mia sorela e i miei Nipoti e mi anno abbonato una troglià di aqua per setimana. Stato fatto dal notaro Stefano Marchesana. “1813. li 26 febraio comprato un pesso di terra gerbido dalla moglie di Gianbatista Rostagni in Bondon per impedire a morti particolari detta che non potesse vortar altra aqua o sia innovare altro bedale." Per quanto invece concerne le liti tra vicini ecco quanto si legge sempre nel manoscritto: "1808. la note delli 25 agosto cioè la matina mi sono alssato ad aurora per andare alla bottega mentre che io drovo la porta sottana vedo calare una croce che era arrenbata alla porta una croce di cana legata con una ena? di canapo in meso era legato tre teghe faiscioli già sechi jo lò presa e baciata e la canservo e questo vorgarmente si diceva che l'aveva avuta alla porta arenbata gioani Moro e suo figlio pe cagione che litighiavimo l'aqua di Bonda. “1808. li 21 Novenbre è cascato mio nipote Gio Antonio Moro giù di un albero di oliva in Camegna e lan adiato dentro un lenzolo. Li 30 è pasato a miglior vita e questo si diceva che lui e suo padre avevan portato la croce alla nostra porta."
Per zone ortili in prossimità dei torrenti o dei canali all'aperto (bedali) che un tempo convogliavano l'acqua al mulino si usava u trabücu o a sigögna, una specie di noria a bilanciere che, applicando il sistema della leva, portava ad una estremità di un lungo braccio un peso (solitamente una grossa pietra) e dall'altro un'asta mobile cui veniva fissato un secchio. Un sistema universamente noto e utilizzato lungo fiumi o laghi. Fu largamente usato dagli Egizi,e lo è tutt’ora, lungo le sponde del Nilo. Fra gli attrezzi caratteristici per dissodare la terra veniva usato u magägliu, specie di zappa che al posto della pala aveva tre lunghi denti di ferro. Maneggiato a due mani, penetrava nella terra e permetteva di sollevare grosse zolle che venivano frantumate con lo stesso attrezzo manovrato a rovescio. Fino a qualche tempo fa era l'unico strumento che permetteva di dissodare la terra nelle fasce e negli orti; oggi, la meccanica moderna l'ha sostituito con piccoli, maneggevoli aratri a motore. L'attrezzo caratteristico delle donne era a messuira, un falcetto messorio simile ad una roncola, ma con la parte tagliente fatta con una lamina sottile, adatta a tagliar l'erba. Era spesso affilata con una pietra di argilla schistosa, a cueta, che gli uomini custodivano in un corno pieno d'acqua appeso alla cintola. Serviva, infatti, anche per arrotare la lunga falce messoira manovrata, sempre, da braccia maschili. Oggi entrambi gli attrezzi sono stati sostuititi da falci a motore. Si deve rilevare che non per tutti le risorse della valle offrirono possibilità di sostentamento, per cui molti abitanti di Isola dovettero lasciare in passato le loro case per cercare lavoro altrove, in particolar modo nella vicina Costa Azzurra o nella zona costiera ligure dove il turismo si andava prepotentemente sviluppando. Un esodo resosi ancor più necessario quando le tre uniche industrie del paese, il pastificio che sorgeva au Gau, una località poco distante dal paese, in riva al Nervia, una fabbrica di fiammiferi costruita all'inizio del paese e la cartiera di cui già si è parlato nella parte storica, furono distrutti dal fuoco o abbandonati per dissesti finanziari.
Foklore domestico: dalla culla alla bara.
La nascita
Sino a qualche decennio fa ancora si conservavano con religiosa tenacia riti, usi e tradizioni, tramandate da lontane generazioni, i quali accompagnavano le varie fasi della vita di ogni uomo. E ciò perchè ogni popolo, in ogni tempo, ha sempre cercato una spiegazione, sia pure semplicistica per qualsiasi atto della vita ottenendo, risultati che a noi paiono puerili, ma che nella loro semplicità ci permettono di penetrare nell'animo di chi li accettò. Nel mistero della nascita, ad esempio, la conoscenza anticipata del sesso del nascituro (fatto che in una civiltà contadina ha sempre una grande importanza), si riteneva di poterlo determinare dalla conformazione fisica della gestante: se la forma del ventre era tondeggiante il nascituro sarebbe appartenuto al sesso femminile; maschile se la forma era a pera. Esisteva un proverbio che recitava "A tripa puntüa a nu porta capèli" (Pancia a punta non porta cappelli, intesi come copricapo femminile). Al neonato, per evitargli il malocchio, veniva posto al collo un nastro con amuleto. In paese si usavano piccoli scapolari, "abitini", formati da due rettangolini di seta ricamata, uniti tra di loro e contenenti all'interno un’immagine sacra. Generalmente gli scapolari erano due, legati all'estremità di due nastrini. Uno di essi appoggiava al torace e conteneva l'immagine della Madonna e l'altro, posto tra le scapole, conteneva l'immagine di un Santo alla cui custodia il bimbo era stato affidato. Al corteo che andava in chiesa, composto dal padre, dalla madre, dalla madrina e dalla levatrice cui era affidato il compito di portare il neonato, si aggiungeva ora un bambino, ora una bambina, che aveva il compito di portare un piccolo recipiente a forma di anfora u tupin o tupinetu o bruchetu (a Dolceacqua era chiamato megietta, ad Apricale duletu) contenente acqua pura con cui il sacerdote, prima del rito, doveva lavarsi le mani. A cerimonia conclusa e dopo il rientro a casa, genitori e parenti del neonato, affacciati ad un balcone da cui pendeva un drappo bianco, lanciavano sul capo della popolazione che affollava la strada o la piazzetta sottostante, noci, nocciole, mandorle. Ai frutti seguiva un lancio di papioti (caramelle) e di ciücarìn, confetti che i più astuti coglievano al volo alzando sopra la testa un parapioggia aperto, tenuto per il puntale. Assai di rado si aveva anche un terzo lancio composto da monetine. Dopo il battesimo la puerpera non poteva recarsi in visita ad amici e parenti se prima non avesse superato il rito della purificazione. Si recava in chiesa e col prete faceva tutto il giro della stessa prima di ricevere la benedizione. A Castelvittorio tale cerimonia era definita con l'espressione pigliar a geija.
Infanzia e adolescenza
Nell'arco della vita di ognuno il periodo più sereno, più giocondo e forse il più felice riguarda la sua inconscia fanciullezza. Lontano dal male perchè non lo conosce ancora, volge tutta la sua attività fisica ai giochi che diventano così lo scopo essenziale e naturale del suo vivere. Tra i giochi che maggiormente hanno resistito all'usura del tempo, e che ancora oggi permangono nel ricordo degli anziani, vi è quello di bedin-bedò fatto con fagioli che dovevano, a forza di bedinate (colpi di pollice), cadere in una buca. Ogni tiro veniva accompagnato dalla formula scaramantica "Bedin-bedò, cärä en tu ciò " (Fagiolo, finisci in buca). Il cian ciapin consisteva in una specie di pampano. E arimete (le piccole anime) altro non era che la versione del gioco 'testa o croce' che si fa con una moneta. Solo che allora veniva eseguito con bottoni di diversa specie. Sembra che in ogni cultura contadina i bottoni abbiano sempre rappresentato qualcosa di importante: basti pensare al bellissimo libro, La guerra dei bottoni scritto all'inizio del secolo dal francese Louis Pergaud. Altri giochi erano: u deliberu, una specie di guardia e ladri; a pimpirinala, la lippa; a sgravaudura, la trottola; Pärte Girölamu, una sorta di moscacieca in cui un fazzoletto non serviva da benda ma solo per colpire e così catturare i compagni che tentavano di fuggire (una variante era u mirorbu, la moscacieca). U nitussu, un gioco che si svolgeva lungo le sponde del torrente, consisteva in una sorta di battaglia fra bande opposte che si scagliavano a nita, il muschio che cresce sott'acqua. U pistuletu era un di gioco di destrezza che consisteva nel lanciare il più lontano possibile un seme, per lo più delle beule d'agäiju (bacche di ginepro) mediante l'uso di un pistuletu, una corta cerbottana ricavata da un rametto di sambuco lungo una ventina di centimetri cui, con un ferro rovente, era stato tolto il midollo.
Tra i giochi dei grandi, in via di estinzione, si possono ricordare a mura, la morra, e u giögu du balun, il gioco del pallone elastico. Quest’ultimo, comunque e per fortuna, tutto il paese tenta pervicacemente di salvarlo e di mantenerlo in auge. A mura veniva giocata da due o più giocatori i quali gridano un numero compreso da zero a dieci, abbassando contemporaneamente e velocemente il pugno chiuso o con alcune o con tutte le dita distese. Vince chi indovina il numero ottenuto dalla somma delle dita distese delle due mani. Un tempo, in prossimità delle poche osterie le urla dei giocatori salivano alle stelle... e le bestemmie di chi perdeva pure. Oggi tutto è silenzio. Il gioco del pallone elastico si svolgeva (e si svolge tuttora) tra due squadre di quattro giocatori che scagliavano un pallone da un capo all'altro di una piazza colpendolo con un pugno. Ogni giocatore usava fasciarsi una mano con una benda per colpire un piccolo pallone di gomma. Un tempo il pallone era formato da liste di cuoio che fasciavano una vescica di animale dentro la quale si metteva il tuorlo e l'albume di un uovo e che poi veniva gonfiata. Durante il gioco l'uovo in continua sollecitazione tendeva 'a montare', a gonfiarsi, il che rendeva sempre più duro il pallone e il colpirlo a pugno nudo o solo bendato diventava pericoloso. Al posto della benda era, pertanto, usato un bracciale di legno che, simile al cesto utilizzato dai pugilatori greci, fasciava la mano sino al gomito. Il gioco del pallone è oggi in via di estinzione per mancanza di spazi adatti. Solo la piazza di Isola, adiacente alla Chiesa parrocchiale si presta in modo egregio allo scopo. In passato una sua variante era u stringhetu. Si trattava dello stesso gioco del pallone elastico eseguito però in spazi più ristretti nei quali non c’era bisogno dell’uso del pugno ma della pättä, cioè del palmo della mano. Veniva praticato nei carruggi dove esistevano case con ballatoi esterni, le cui scale venivano usate come "rampa di lancio".
Fidanzamento e matrimonio
Il periodo del caregnää (amoreggiare) faceva parte dell'eterno gioco dell'amore. Gli innamorati, a seconda del paese, avevano una denominazione particolare. A Isolabona, ad esempio, lui veniva definito bardäsciu, un termine oggi totalmente desueto il quale aveva il significato di giovane da marito. Lei, a Dolceacqua, veniva definita u s-ciancurelo. Tale parola ha anche un altro significato e sta ad indicare un grappolino d'uva. Un gentile omaggio di galanteria che i giovani fanno alle fidanzate paragonandole a chicchi d'uva che oltre a contenere zucchero possono anche, col loro contenuto, far girare la testa. Vigevano pratiche ingenue che permettevano alle ragazze di sapere se si sposavano entro l'anno. Ad esempio una sartina che cercava un capo del filo in una arruffata matassa se non lo trovava rimaneva zitella. Ogni ragazza, per sapere se avrebbe sposato un uomo ricco, nascondeva sotto il cuscino tre fave di cui una con la buccia, una sbucciata a metà e l'altra interamente. Durante la notte, al buio, ne sceglieva una e avrebbe così saputo se il futuro marito sarebbe stato una persona ricca, parzialmente benestante o povera. Esisteva pure il sistema di gettare il primo giorno dell'anno una pantofola contro la porta: se questa si fermava con la punta rivolta verso l'uscio significava che la ragazza si sarebbe sposata entro l'anno. Il De Gubernatis, nel suo libro Storia comparata degli usi nuziali in Italia (Milano, 1869) rileva che persino in Russia vigeva un uso analogo e scrive "si gettava una pianella sopra la strada; lo sposo dovrà arrivare da quella parte verso la quale si volge la punta della pantofola". Per informare i genitori dell'intenzione di sposare la loro figlia l'interessato era solito porre sulla soglia di casa della prescelta ün ciücu, un piccolo ceppo d'ulivo. Se il giorno dopo il ceppo non c'era più era segno che i genitori approvavano la proposta. Poteva accadere che qualche buontempone, per divertimento, portasse via nottetempo il ceppo o che un innamorato respinto lo trafugasse per impedire il matrimonio. Poteva pure accadere che qualche pretendente, ignaro di essere stato preceduto, ponesse a sua volta il ciücu. In questo caso la famiglia pregava il banditore del paese, u batiuu da cria, di passare di caruggio in caruggio suonando una trombetta e informando la gente che si affacciava alle finestre: "U s'avarte che chi ä messu u ciücu sciü a porta de (seguiva il nome della famiglia) de andärlä a descciücää perché a giuvena a l'a giä enciücä" (Si invita colui che ha messo il ceppo sulla porta della famiglia (...) di toglierlo perché la giovane é già promessa). Tale uso, scrive Giuseppe Ferraro, si riscontra anche a Serra San Bruno di Calabria dove "l'amante usa di notte mettere davanti alla casa della ragazza, da lui presa ad amare, un ceppo adorno di nastri, fazzoletti ecc. Se il ceppo é ritirato, la ragazza accetta l'amor suo, se no i parenti dicono : 'Non abbiamo figlie da marito' e allontanano il ceppo". Analogo uso si riscontra anche nell'Abruzzo". A Isola gli innamorati respinti talvolta si vendicavano imbrattando la porta della ragazza con sostanze maleodoranti o le cantavano serenate con ingiurie più o meno sconce. Eccone due riferite da un vecchio di Isolabona il quale, mentre le declamava, rideva forse ricordando la sua gioventù e i suoi trascorsi.
Bigina a Sciäcästrässe, Bigina Schiaccapanni (Lavandaia?) a figlia du bastéé , la figlia del maniscalco Cun tütte e sue cumpagne con tutte le sue compagne che stän per lu cartié, che abitano nel quartiere a seira a vä en retréta di sera si apparta cun tütti i giuvenoti con molti giovanotti e, envece de camije e, invece delle camicie, a ghe stira i manegotti. stira loro i manicotti. Sti giuvenotti pöi, Di questi giovani poi a nu ve ne digu ran. io non vi dico nulla, ché a ne dirìa trope perché ne direi troppe e u nu starìa ban. e non sarebbe conveniente.
Gardei che bala scöra Ma guardate che insegnamenti a n'ä mustrau en Acòla, hanno impartito ad Acòla, sta troia de Girola, a questa troia di Girola, sta cavälä. questa cavallona. Caväle de omi frusti Cavallone di uomini frusti a nu n'ämu mai vusciüu. non ne abbiamo mai volute. Adassu a me ne riu E adesso me ne rido de tue belesse. delle tue bellezze.
Poteva pure accadere che due innamorati, per rivalità fra le loro famiglie tentassero di tenere nascosta la loro relazione. Non era raro che qualche pretendente respinto rendesse nota tutta la faccenda tracciando per terra un caminetu de sene (sentiero di cenere) una lunga striscia di cenere che dalla casa di lei andava sino a quella di lui, e informando così tutto il paese. Tali camineti de sene si tracciavano pure quando una donna sposata aveva una relazione illecita; in questo caso la striscia di cenere non iniziava dalla casa della donna, ma, in senso di disprezzo, incominciava dalla porta della sua stalla. Totalmente scomparso in tutta la vallata l'uso riguardante i fidanzamenti fra giovani di paesi diversi. Consisteva nel far pagare una somma a chi veniva a sposare una ragazza in un paese non suo. Era forse questa una reminiscenza del diritto familiare longobardo in cui era stabilito che, qualora un matrimonio avvenisse fuori della Sippe, lo sposo doveva pagare alla Sippe il guidrigildo pari al valore della sposa che si considerava in certo qual modo rapita alla sua comunità . Un’espressione caratteristica era ancora in uso alcuni decenni or sono per indicare le pubblicazioni di legge che venivano esposte nelle bacheche del municipio e della chiesa. Riferendosi ai due fidanzati si diceva i sun en ta gäggiä, sono nella gabbia, una allusione per indicare che il matrimonio era una trappola a due. La cerimonia nuziale non presentava nulla di caratteristico, tranne l'analogia col battesimo. I due sposi, infatti, erano soliti lanciare dalla finestra ciucarin, papioti e ciapelette dolciumi vari, per lo più caramelle, nonché noci e mandorle. L'uso romano che la poesia di Catullo ha tramandato rimase a lungo vivo nella memoria degli Isolesi: "Ne diu taceat procax/fescennina iocatio,/ nec nuces pueris neget." Il lancio delle noci conferiva alla cerimonia un sottile senso di melanconia in quanto stava a significare l'addio ai giochi dell'infanzia e l'abbandono della puerizia. Era una malinconia subito fugata durante il pranzo nuziale;perché non mancava mai qualche commensale che intonava strambotti e stornelli salaci che facevano arrossire la sposa. In questo vi era ancora un ricordo della "fescennina licentia" di cui il poeta latino parla nel suo carme dedicato al matrimonio di Manlio Torquato e Vinia Arunculeia. Circa il disfavore per le seconde nozze e l'uso del ciaravügliu si rimanda alla parte IV del libro dal titolo “L’aria di ponente”.
Funerali
Ancor oggi è consuetudine avvertire la comunità della morte di un suo componente mediante il suono delle campane, i cui rintocchi variano secondo il sesso; tre brevi serie di rintocchi se il morto è un uomo, due se una donna. Un tempo si usava pure "suonare l'agonia", consistente in brevi rintocchi cadenzati che risuonavano a lungo e duravano finché la persona non fosse morta. A morte avvenuta il primo atto era quello di aprire le finestre, atto dettato dall'ingenua credenza che l'anima potesse volare via libera, poi le persiane venivano chiuse. Ogni specchio veniva coperto da un drappo per evitare, come scrive Van Gennep, "de laisser le cadavre se reflechir", in quanto l'anima, se morta in stato di grazia, vedendosi bella nello specchio, per un eccesso di narcisismo, non si decidesse a liberarsi dal corpo. A Isolabona vigeva l'uso di legare con una fettuccia le caviglie del morto e, in tempi assai antichi, di mettere in bocca ad esso una moneta: reminiscenza dell'obolo pagano con cui si voleva che il defunto pagasse il pedaggio per essere traghettato nell'aldilà. Il Rossi, citando un passo del "Procaccino ligure", a proposito del corteo funebre scrive: "circa le tre del mattino mi pervenne confusamente all'orecchio un lungo e continuato scampanio. Balzato dal letto e aperte le imposte di una finestra che mette su una piazza vidi avanzarsi una lunga processione di battuti che con torchie facea corteo ad un feretro. Lo seguivano femmine in veste bruna, discinte, scarmigliate, coperto il capo di larghi cappellacci, le quali battendosi il petto e le guancie rompevano in acutissimi gridi di dolore. Attorno al defunto poi deposto non in una bara ma sopra un lettuccio e vestito de' migliori suoi abiti, stavano tutti i più prossimi parenti. Non tardai a richiamare in mente le "preficae", i "vespillones", i "lectuli" e le "neniae" dei romani e mi convinsi dei riscontramenti che nelle usanze funerali si conservavano tuttora". Di tale uso non ho riscontrato alcuna memoria nei vecchi isolesi intervistati. Concluderemo segnalando ancora un antico costume isolese. Sino all’inizio del secolo scorso si credeva nel ritorno temporaneo dei morti nel giorno della loro annuale commemorazione. Al mattino i familiari, prima di recarsi in chiesa per la messa, avevano l'avvertenza di mettere lenzuola pulite nei letti, di lasciar in ordine ogni cosa, di preparare sul desco cibi e bevande e di porre un lume acceso in cima alle scale per dar modo al congiunto morto, se fosse ritornato, di rifocillarsi e di riposarsi.
Magia, stregoneria e credenze popolari.
Nei vari paesi della valle, di generazione in generazione, si sono tramandate una serie di conoscenze, di opinioni e di pratiche che abbracciano molte delle scienze relative alla sfera della natura, e del magico e dell’occulto. La maggior parte delle nozioni è frutto di un’esperienza fatta e collaudata direttamente dal volgo; un'altra parte deriva dalle briciole di quelle scienze occulte che parecchi secoli fa erano molto in auge. Benché la scienza occulta anticamente fosse esclusivo predominio di un’esigua casta, ciò non toglie che qualcosa dovette trapelare e incidere profondamente sulle credenze del popolo. Venendo a parlare più in particolare delle streghe e delle loro azioni, occorre risalire addietro nel tempo per avere una visione di quanto tali credenze fossero estese non solo nel popolo ma anche tra i dotti. E se delle leggi emanate a suo tempo contro di esse non rimane traccia se non in polverosi documenti, ho avuto modo, interrogando vecchi isolesi, di constatare che, pur sorridendo all'accenno alle streghe, qualche antico timore è ancora presente. E tali persone, attraversando località note per essere state luogo di convegno di streghe o scursi o barbetti, furtivamente si fanno ancor oggi il segno della croce. Gli scursi, nati nella fantasia popolare, non avevano una personalità definita, ma dai segni che, si dice, abbiano lasciato doveva trattarsi di esseri giganteschi, dotati di una forza prodigiosa. Si racconta che gli scursi si divertissero a giocare a pallone servendosi di enormi macigni, i quali, colpiti da possenti pugni, volavano da un monte all'altro. Di tali macigni se ne trovano un po' dovunque e con un pizzico di fantasia si possono scorgere le impronte dei pugni ricevuti da detti giganti. In una località vicino ad Isolabona, chiamata Permean c'è un macigno di tal genere, del peso di parecchi quintali, il quale avrebbe sorvolato la valle - 700 metri in linea d'aria - dopo essere stato colpito da uno scursu. I barbetti hanno una origine più recente. Risalgono alla seconda metà del 1700 e servivano soprattutto come spauracchio per i bambini. Per essi esiste un riscontro storico; si trattava di una banda di Savoiardi scesi nel 1745 nelle valli della Liguria di ponente dove seminarono terrore e morte. Sul capo del loro comandante, certo Olivieri da Cuneo, famigerato per i suoi orrendi delitti, pendeva una taglia di mille doppie, messavi dall'infante di Spagna. Tutti barbetti e il loro capo furono catturati in una grotta dei Balzi Rossi presso Mortola. (N.Peitavino, Intemelio, p.309). Ad essi sono legate alcune vicende di cronaca isolese che André Cane ha riportato nel suo libro Au fil du Nervia. A pagina 99 riferisce di una esecuzione capitale, avvenuta nel 1795, in cui furono coinvolti i fratelli Giuseppe e G.B.Veziano, rei di aver fatto parte della banda dei barbetti e di essersi resi colpevoli di "omicidi fatti ai francesi" nella zona di Forcoino. Il Cane racconta pure un fatto accaduto al suo trisavolo. Questi, causa la carestia allora imperante, si era recato a Saorgio per comprare un sacco d'orzo. Sulla strada del ritorno i doganieri l'avevano fermato e gli avevano confiscato la merce, lasciandolo poi libero di tornare a Isolabona. In un bosco di imbatté in un gruppo di barbetti ai quali narrò la sua disavventura. Questi lo invitarono a condurli dove stavano i doganieri e, sotto la minaccia delle armi, pretesero la riconsegna del sacco confiscato al proprietario. Il che avvenne. La parte più pittoresca che colpiva la fantasia del popolo era indubbiamente il "gioco delle streghe", cioé la loro riunione in luoghi prestabiliti, durante la quale si rendeva omaggio al Signore delle Tenebre. Luoghi di raduno furono Castellaro (vicino a Mentone) per le streghe di Camporosso; il Valun de la Papeira e la Rocca per quelle di Dolceacqua e Isolabona. E queste ultime avevano anche un altro luogo di ritrovo assieme a quelle di Apricale, sotto un noce, cresciuto vicino al torrente Merdanzo. Ma la località aveva poca importanza perché, preparando un intruglio composto di polvere di rospo, sangue di dragone, ossa di morto, il tutto rimescolato con un bastone di avellano, e pronunciando la frase "Gira, gira, balu bastun e fäme vurää dunde e autre e sun" (Gira, gira, bel bastone e fammi volare dove stanno le altre", le streghe potevano recarsi dove volevano. Nicolò Peitavino, nel suo libro Intemelio, riferisce di alcuni processi tenutisi nel XVI e nel XVII secolo. A Baiardo, nel 1588, venne sottoposta a tortura certa Marietta Ausenda, rea di aver partecipato al "gioco". Nel 1622 fu intentato un processo contro Peirineta Raibaudo incriminata d'aver fatto morire alcuni ragazzi mediante malefici, di essersi tramutata in una gatta e di aver avuto commercio col diavolo. Costei, sotto la tortura, ammise di essersi fatta togliere i segni della Cresima e del Battesimo da due stregoni di nome Miran e Barroban. La Raibaudo, dopo aver abiurato fu strangolata e poi bruciata. A discolpa della disgraziata Peirineta dobbiamo rilevare la testimonianza di un rettore della valle, certo Bernardino Balauco, che asserì essere la donna inferma di mente. In quei tempi, però, la pazzia era considerata un derivato delle pratiche di stregoneria. Che tale processo abbia avuto una eco in Isolabona lo dimostra il fatto che, quando scoppia un temporale e lampi e tuoni si succedono in continuità illuminando di lividi bagliori il cielo e facendo risuonare i boschi alle pendici del Toraggio, si è soliti dire ai bambini che è il baraban adirato che si scatena. Ora dal Barroban di cui si parla negli atti del processo al baraban deve per forza esistere una connessione. E' fuor di dubbio che in mezzo alla gran massa credulona e ignorante si insinuarono furbi e ciurmadori per portare a termine i loro disegni. Le donne venivano così suggestionate dietro facili promesse e condotte ai più delittuosi eccessi. Forse è per questo che si parla più di streghe e raramente di stregoni. Tali credenze si sono, in tempi recenti, riassunte in quello che viene definito malocchio, gettato addosso a qualche malcapitato da fautureire o bäzure" (fattucchiere) attraverso una carezza o con lo sguardo o l'offerta di qualche oggetto. Per toglierlo esistevano pratiche che variano tra paese e paese. Ad Isolabona, ad esempio, se si riteneva che a un bimbo fosse stato gettato il malocchio si procedeva nel seguente modo: si faceva bollire l'arba da Madona (Plantago maior o piantiggine) in molta acqua e in essa si immergeva il bambino. Se l'acqua si rapprendeva come latte cagliato era segno che il bimbo aveva il malocchio e di conseguenza, per toglierlo, lo si doveva immergere tre volte consecutive. Se durante l'operazione accadeva che qualche donna venisse a bussare all'uscio, quella era la iettatrice. Più a lungo sono durate le 'superstizioni spicciole', sebbene la loro presenza sia oggi molto sbiadita nella mente della gente. Ecco le poche tracce riscontrate in colloqui con anziani. - Se durante una processione una croce viene casualmente appoggiata al muro di una casa, durante l'anno avverrà in quella casa una morte. - Uscendo di chiesa non occorre intingere la mano nell'acquasantiera e farsi il segno della croce, perchè si riprenderebbero i peccati che, entrando, erano stati cancellati dall'acqua lustrale. - Ogni madre deve evitare di lasciare i pannolini del bambino stesi durante la notte perché qualcuno potrebbe attraverso essi gettare il malocchio. - E' vietato seminar prezzemolo se non si vuole morire entro l'anno o far morire il più anziano della famiglia. Il prezzemolo non si pianta, si trapianta. - Se un pettine scappa di mano devono arrivar notizie. Così pure se il fuoco soffia nel camino. - E' segno infausto se u ganavelu, la civetta, si posa su una casa. - E' fatto divieto alle donne in stato di gravidanza portare amuleti o collane o bracciali a forma di serpente, perchè potrebbero strozzare il feto. - Versare olio, rompere specchi, spargere sale è presagio di grandi calamità . - Mai gettare capelli e unghie dalla finestra. Potrebbero essere usati per sortilegi o malocchio. - Vietato indicare col dito le cucubirtacee attaccate alla pianta perchè si anegiano (se ne interrompe la crescita e appassiscono). ... e l'elenco potrebbe continuare
Medicina popolare antica
La farmacopea moderna ha, lentamente, finito per "uccidere" tutti quei mezzi empirici di cui la popolazione si è avvalsa per far fronte ai mali del corpo. Poco è rimasto se non quelle cure a base di erbe che, pur non essendo troppo ortodosse, possono venir accettate in base ai dettami della Scuola salernitana. A sparire totalmente sono stati quei metodi tanto strani assurdi e spesso contrari ad ogni norma igienica che ci si chiede se non sia stata una mente malata a idearli. Si è, comunque, tramandato il ricordo di alcune cure che, per amor di cronaca, è interessante ricordare. Di due di esse, come osserva L.T. Belgrano, negli Atti della Società Ligure di Storia Patria (vol. XIX, p.645), si trova traccia persino in un codice genovese di medicina e scienze occulte. Si tratta del modo di resistere al dolore. Il primo recita: "Accipe lac mulieris, videlicet matris et filiae dictae matris, et isti duo lactes simul miscantur deinde dentur in potu antequam accedat ad turmentum: et non timebit". Una ben strana medicina da somministrare a coloro che stavano per essere torturati! Il secondo serviva nelle prove ordeali. G.Rossi riferisce che anche in Val Nervia un accusato poteva dimostrare la sua innocenza in un modo semplice: afferrando con una mano un ferro rovente. Se il ferro non lasciava traccia era libero; in caso contrario doveva subire la pena. Ebbene, per superare tale prova, si legge nel manoscritto genovese, "accipe sucum mircoyrolle [specie di euphorbia] et unge cum eo manus tuas optime et accipe ferrum in manum et non nocebit". Dagli atti del notaio De Amandolesio, citati da N. Peitavino nel suo libro Intemelio (p.140) ricaviamo due altri sistemi curativi che servivano l'uno ad attutire i dolori del parto e a preservare la puerpera dalla morte; l'altro ad arrestare un flusso di sangue. Per il primo si doveva scrivere sopra un pezzo di carte il noto quadrato magico
S A T O R A R E P O T E N E T O P E R A R O T A S
Bastava legare il foglio alla coscia destra della partoriente e l'effetto era sicuro. Per il secondo rimedio occorreva una gallina che non facesse uova e dalle ali si faceva uscir sangue con cui scrivere sul polso e sul capo dell'ammalato, mediante una fraschetta di ulivo benedetto, le seguenti parole "Consumatum est". Il suddetto sistema con la gallina, un po' variato, serviva anche come rimedio contro le cadute. Si prendeva un gallo, gli si tagliava un pezzettino di cresta, si raccoglieva in un cucchiaio il sangue zampillato che, ancora caldo, si somministrava al paziente. L'operazione si ripeteva per diversi giorni. Quando il gallo non aveva più cresta, l'ammalato era guarito, Altro metodo in uso a Isolabona era quello di porre sopra una ferita aperta una ragnatela per fermare il sangue. Ho visto una vecchia metterlo in atto per un taglio alla mano. Un paio di giorni appresso la ferita si era cicatrizzata. Altri sistemi. - Contro i vermi si faceva odorare ai bambini un tipo speciale di erba rua (Ruta graveolens) dell'aglio pesto; oppure si metteva loro al collo una collana fatta con spicchi d'aglio; o ancora si faceva loro bere un cucchiaio di succo di erba caramandrina - Contro gli orecchioni esisteva un curioso sistema. Si prendeva un grosso sacco sporco internamente di farina, vi si introduceva la testa del bimbo e si agitava il sacco; a cura terminata, il sacco veniva buttato giù dalle scale. - Per guarire u mää du grupu" (difterite) si faceva bere al paziente un disgustoso intruglio composto di urina, limone spremuto, vino bianco moscatello e olio. - Per il mal di denti bastava applicare sulla guancia dolorante un impasto di lumache o meglio ancora di durmigluse , piccoli insetti fasciati da un tegumento chitinoso i quali, appena toccati si appallottolano come ricci). - Oppure si pestava aglio e lo si applicava sul polso opposto alla guancia dolorante. Il mal di denti dopo alcune ore passava. Il contadino che mi spiegò il sistema mi fece pure vedere il suo polso su cui, a distanza di anni, si notava ancora la pelle bruciata dai solfuri contenuti nel succo dell'aglio. - Per guarire le risipole si poneva su di esse una moneta e poi con un coltello o un anello benedetto si facevano piccoli segni segni attorno alla moneta, recitando contemporaneamente il "Confiteor". - Per accelerare un processo infiammatorio occorreva porre sulla parte malata dello sterco di vacca. - Le ecchimosi guariscono se su di esse si applica un impiastro composto di sängure spargure (Parietaria officinalis), föglie de levantùn" (Verbascum thapsus) e aceto. - Per accelerare lo sviluppo della rosolìa il fanciullo veniva avvolto in un drappo rosso. - Per guarire u russignö (crampo alla mano) era d'uopo legare al polso un filo di lana rossa. - Per mali interni era consigliato di inghiottire lumache vive (bagiäire). Per quanto esistessero altri sistemi empirici, mi limiterò a citare ancora quelli riportati da Dino Taggiasco nel suo libro Bordighera e uno raccolto dalla viva voce del guaritore che, ancora cinquant'anni fa lo metteva in atto. Racconta il Taggiasco che i colpi di sole "si guarivano da comari specializzate alle quali occorreva comunicare preventivamente il nome del sofferente. La comare faceva bollire mezzo pignatino d'acqua e vi metteva dentro tre grani di sale da cucina, accompagnando ognuno con tre Ave Maria e diversi Oremus; poi capovolgeva il pignattino in un piatto. Dopo 36 ore lo toglieva con la mano sinistra. L'aria esterna, occupando il vuoto, emetteva naturalmente un piccolo sparo, il cosiddetto "petu". Dalla forza del "petu" la comare giudicava se la persona - indubbiamente guarita - poteva avere o meno conseguenze gravi". Altro sistema consisteva nel porre sulla testa dell'ammalato un asciugamani bianco, piegato più volte, e su questo veniva posto rovesciato un bicchiere pieno a metà d'acqua. Nell'acqua si formavano bollicine che salivano in superficie, tanto da dare l'idea che il liquido bollisse. Dopo una diecina di minuti il colpo di sole spariva. Sempre al Taggiasco dobbiamo il ricordo di questa cura per bambini effettuata da una donna di Ospedaletti. "La Cumà faceva alcuni segni di croce sulle mammelle della madre e sul capo del piccino. Poi appendeva al collo di questo un sacchetto con tre, sei oppure nove grani di sale da cucina, a seconda della gravità del male, ed ordinava un 'caffè ' fatto con ossi di pesco abbrustoliti, qualunque fosse la malattia, anche se il piccino avesse avuto putacaso un'unghia incarnata od un foruncolo su un piede." L'ultimo sistema empirico per curare malattie comuni era la "misurazione dello stomaco", cui ho personalmente assistito. Nella valle vi era una sola persona capace di effettuarlo, un certo signor Battista C. di Isolabona. Quando uno accusava sovente mal di stomaco veniva curato nel seguente modo: lo pseudo medico prendeva uno spago lungo tre volte la distanza che andava dal suo gomito alla punta del suo dito medio. Detto spago lo si consegnava al paziente affinché lo tenesse premuto sul petto. Poi con esso eseguiva per tre volte la stessa misurazione sul paziente. Se le tre misurazioni erano esatte il male era di poco conto e di sollecita guarigione. Se, invece, lo spago non bastava o ne avanzava, significava che lo stomaco si era abbassato o rialzato della stessa lunghezza dello spago che mancava o che cresceva. In tal caso bisognava replicare per tre giorni le misurazioni affinché lo stomaco andasse alla giusta altezza.
La cucina isolese
La cucina isolese non si discosta molto da quella ligure, tranne alcune particolarità degne di essere menzionate. Una ghiottoneria negli antipasti è rappresentata dai ciücotti, piccoli funghi che vengono conservati in salamoia sott'olio. Tra i primi piatti che le massaie facevano nei bei tempi antichi v'erano i menieti formati con farina bagnata, fregata tra le mani e lasciata cadere in acqua bollente. Si otteneva una specie di pappa molle, a grumi, assai nutriente. Una variante erano i menieti dusi, che si ottenevano usando farina di castagne. Assai graditi erano un tempo i beroudi (sanguinacci) fatti con sangue di porco, latte, pinoli, il tutto insaccato in budella e ventricoli. Si consumavano in brodo oppure tagliati a fette fritti. Oggi maiali non se ne allevano più in tutta la valle. Nel periodo pasquale erano di moda i massetti, cioè le interiora degli agnellini o capretti da latte le quali venivano attorcigliate a mo' di gomitolo su una mano, legate e messe a cuocere in salsa bianca. Di largo consumo fu pure u fugassun una specie di torta simile alla torta pasqualina genovese, fatta però di sole erbe e cotta nel forno comune in grosse teglie di rame, annerite dall’uso, del diametro di 80 cm. circa. Su queste si stendeva una sottile sfoglia di pasta, lavorata sciü u tagliauu (sul tagliere rotondo), e su di essa si versava un impasto di erbe, in prevalenza bietole bollite, strizzate, tritate e condite con olio e sale. Il tutto veniva poi ricoperto da un'altra sfoglia di pasta dello stesso diametro della prima. Era facoltativo mettere sulla sfoglia superiore olive o spicchi d'aglio. Quando u fugassun veniva cotto nel forno comune la massaia era solita contrassegnarlo con un simbolo e un tempo vigeva l'uso di non pagare il fornaio ma di ricompensarlo con un fugassun in formato ridotto detto u pagun che si lasciava al fornaio. I fugassui in formato ridotto potevano anche essere cotti nella padella e si otteneva così u fugassun en ta paala. Una variante erano i barbagiuäi, grossi ravioloni ripieni d'erbe, lasciati attaccati a due a due e fritti. Tra i dolci le cubäite sono quelle che maggiormente hanno resistito nel tempo. In qualche famiglia ancora oggi vengono fatte nel periodo natalizio. Sono praticamente un vanto della cucina isolese. Le cubäite sono formate da un sandwich composto di due ostie rotonde del diametro di quindici centimetri, sovrapposte. Tra di esse viene messo un composto formato con nocciole e noci grossolanamente tritate, cotte in molto miele. Le cubäite vengono distese su un tavolo, coperte dal tagliauu, un grosso tagliere rotondo, e lasciate finchè il miele non si è rassodato. Le ostie venivano fatte artigianalmente mediante un grosso forbicione che al posto delle lame aveva due dischi di ferro del diametro di quindici centimetri, sui quali era impresso un marchio o le iniziali del capo famiglia. Per fare le ostie bastava mettere i due piatti a contatto col fuoco, scaldarli sino ad una determinata temperatura e versare sopra uno di essi un cucchiaino di pastella di farina assai diluita. Bastava chiudere le forbici perchè la pasta si spandesse e l'ostia prendesse forma.
Feste profane
La prima era il Carnevale che non presentava usi particolari tranne la tradizione dello scürottu, (vedi la III parte "Aria di ponente"). In disuso sono pure cadute le tradizioni riguardanti il mese di maggio (le maggiolate). Il secondo conflitto mondiale le ha "totalmente uccise", forse perché la tragedia bellica cancellò quel motivo psicologico e quel senso di stupore e di ammirazione che l'uomo riceveva di fronte all'erompere della vita nella natura. Ancora viva nella memoria dei vecchi è, comunque, la cerimonia del "piantar maggio", allorché i giovani trascinavano da uno dei boschi circostanti un pino privato dei rami, ma non della punta, e lo piantavano in mezzo alla piazza. Non aveva nulla a che vedere con l'albero della cuccagna, sebbene negli anni che precedettero la sua scomparsa si tendesse a mettere in cima dei premi in natura e anche in denaro. Sempre di maggio, nei vicoli le donne e le ragazze attaccavano cordicelle da un muro all'altro delle case su cui appendevano corone fiorite che venivano rinnovate ogni sera con fiori freschi colti nei campi. Poesia d'altri tempi.
Festività religiose
Lo spirito religioso ancora oggi presente nelle manifestazioni legate a particolari culti si è, invece, andato lentamente affievolendo in quelle manifestazioni esteriori che un tempo facevano da corollario al primo. Ad ogni festa era collegato qualche spettacolo che variava da paese a paese, e che a lungo andare si focalizzò in uno solo e fu tramandato di generazione in generazione senza che nulla fosse mutato. Dopo l'ultimo conflitto alcune di queste funzioni sono state abbandonate; altre hanno vissuto saltuariamente per poi cedere al progresso che tende a livellare ogni cosa. Iniziando dalla festa per eccellenza, il Natale, ancora in vita è l'uso di fare il presepe, di addobbare l'albero (oggi in plastica, un tempo prelevato, dopo ore di cammino, nei boschi di Langan o au Passu du rebissu (Passo dell'usignuolo) non con le moderne palle colorate e fili argentati o puntali dorati, ma con caramelle, cioccolatini, mandarini, aranci, noci, ... La vigilia era contrassegnata da una cena a base di stoccafisso bollito con patate e frittelle di baccalà. Altri invece, scrive Stefano Rebaudi in Monografia di Imperia, consumavano u grän de Natäle e così spiegava: "Il Dio di amore, di misericordia, il quale nasce per redimere l'umanità, non può essere più degnamente glorificato dal lavoratore dei campi, che con l'offerta ed il sacrificio del grano, il prodotto più nobile ed eletto della terra, l'alma mater, madre amorosa e soavissima." "Ed ecco quali sono le modalità, che informano il rito natalizio del grano... Il 'grano di Natale' per essere reso commestibile dev'esser liberato dalla crusca o cruschello; occorre perciò sia sottoposto ad una operazione di pilatura, di brillatura, di imbianchimento... che viene condotta durante il pomeriggio della vigilia." Per l'operazione occorreva: "un mortaio ed un pestello di grandi dimensioni, costruiti grossolanamente in paese, utilizzando legno durissimo di sorgo o di castagno: i strumenti che si trasmettono in eredità di padre in figlio. Il mortaio (denominato 'broeglia') di rozze fattezze, scavato in un tronco d'albero, presenta suppergiù le seguenti dimensioni: altezza 38 centm.; massima larghezza in alto 36 centm.; profondità del cavo interno 22 centm.; spessore delle pareti 4 centm.. Il pestello, denominato in dialetto "pistun" che misura in altezza centm. 20 circa ed è munito di un manico pure in legno della lunghezza di 60 centm. circa, può avere due forme. Nella forma più comune, costituita da due pezzi, il manico si innesta ad angolo retto entro l'impugnatura del pestello; nella forma meno frequente, pestello e manico sono costruiti in un unico ramo d'albero opportunamente scelto per la bisogna." "Nel pomeriggio della vigilia, per solito, uno degli uomini di casa, si siede sui gradini o sulla soglia dell'abitazione e quivi disposto il mortaio che riempie di grano grezzo, col pestello impugnato per il manico a due mani, inizia l'operazione di pilatura, che a colpi cadenzati vien condotta sino a che i chicchi siano lucidi, bianchi, splendenti ossia siano spogli della cuticola. Il grano viene frequentemente spruzzato con acqua calda, e per liberarlo man mano della crusca che si stacca e seguirne il grado di imbianchimento, l'operatore ne solleva dal mortaio delle manciate su cui soffia con forza. Il mortaio sarà riempito parecchie volte, sino a che si raggiunga il quantitativo necessario ai bisogni della famiglia. Il grano sopporta una bollitura piuttosto prolungata in abbondante acqua cui si è aggiunto sale, della cotica di maiale e qualche pezzo di carne magra di agnello. Al ritorno dalla messa di mezzanotte, riscontrato il grado della cottura del grano (deve essere molto rigonfio ma non spappolato) si toglie da fuoco e, dopo aver posto in serbo la quantità da consumarsi nei giorni successivi, si passa alla confezione della vivanda. Viene scodellato in un gran piatto profondo di terra gialla a fiorami, ove si condisce con un soffritto all'olio a base di porro: ortaggio che si coltiva quasi esclusivamente per aromatizzare il grano di Natale, cui dona un profumo e un sapore appetitosissimi. Il gran piatto è deposto nel centro della tavola e da questo tutti i commensali pescano col rispettivo cucchiaio il grano benedetto del Santo Natale." (p. 255) Purtroppo la tradizione è completamente scomparsa. Oltre all'accurata descrizione del Rebaudi, ho raccolto una sola testimonianza in paese da una donna ultranovantenne. Sempre nella notte di Natale viene acceso un grande falò in mezzo alla piazza, dove nei giorni precedenti i ragazzi, passando di porta in porta, chiedendo "Pe u fögu du Bambin däine di ciüchi e di bigliui" (Per il falò di Natale dateci ceppi e tronchi), hanno ammucchiato una grossa catasta. Il fuoco veniva appiccato al momento del Gloria e durava tutta la notte. Un tempo alla messa di mezzanotte partecipavano pure i pastori avvolti in ampi mantelli, con fasce alle gambe, grossi scarponi e un cappello a punta coperto di fronzoli. Il più anziano portava tra le braccia un agnellino, l'ultimo nato. La tradizione di Capodanno consisteva nel giro del paese che la banda musicale faceva, soffermandosi in ogni vicolo, suonando e ricevendo vino e cibarie che venivano consumate quella sera stessa in una grande "ribotta", specie di cenone organizzato dai suonatori. Recita un proverbio isolese: "A Pifania tütte e faste a porta via, Carlevää u e turna a menää" (l'Epifania porta via con sé tutte le feste. Carnevale le riporta). Tra queste c'è la Pasqua. Per quanto riguarda la Processione del Giovedì Santo si rimanda alla Parte IV "Aria di ponente" Di caratteristico nei giorni che precedono la Domenica di Pasqua accadeva che, non essendo permesso dalla liturgia l'uso delle campane, non si potessero avvertire i fedeli dell'inizio delle funzioni religiose. Entravano allora in funzione le tarabale il cui suono richiamava la gente in chiesa. La tarabala era costituita da una tavoletta di legno (30x40 cm), munita di maniglia, sulla quale venivano attaccati, da entrambe le parti, due ferri disposti a batacchio. Quando erano agitate, producevano un suono ritmico. Le usavano solo i ragazzi. Ogni bambino a Pasqua aveva il suo uovo, non di cioccolato: si trattava di un vero uovo sodo, col guscio colorato in marron, rosso, verde, dopo averlo fatto bollire in fondi di caffè, in acqua di barbabietola o in radici di ortica. Se si voleva essere più originali e disegnare l'impronta di un fiore sul guscio, si avvolgevano in carta oleata le uova cui preventivamente erano stati legati fiori particolari, le beciciure de gatu (Muscari comosum) che hanno la forma di gladioli in miniatura e sono di colore violaceo. Durante la bollitura lasciavano sul guscio forma e colore. Con dette uova si faceva il gioco dello scussetu. Due bambini picchiavano le loro uova l'una contro l'altra, vinceva chi rompeva l'uovo dell'avversario. E' questo un uso, spiega A. De Gubernatis, in vigore presso i latini, i Germanici e gli Slavi ed era considerato di lieto presagio e augurio. Altre feste tradizionali erano San Giovanni (24 giugno) e S. Luigi (21 giugno) La prima cade al principio dell'estate e veniva solennizzata da grandi falò accesi dalla popolazione. La differenza nei falò rispetto a quello di Natale consisteva nel fatto che il falò di Natale era unico mentre quelli di di S. Giovanni ardevano ovunque, e inoltre a S.Giovanni non si bruciavano grossi ceppi o tronchi ma erba, fieno, paglia, rami d'ulivo, viticci. Nell'uso di falò nella notte di Natale e in quella di S. Giovanni lo studioso Pola Falletti ha voluto vedere una reminiscenza di antichi riti pagani, in uso presso gli antichi Celti. A suo parere i fuochi non erano accesi per solennizzare una festività religiosa e non a caso essi avevano luogo al solstizio d'inverno e al solstizio d'estate. Se si pensa alla conoscenza che del cielo avevano gli antichi, si potrà dedurre come debba essere loro apparso un fenomeno inconsueto e forse magico, il fatto di vedere il sole nel primo punto del Cancro cessar di alzarsi sopra l'equatore e sembrar quasi fermarsi per poi incominciare a calare; e verso il 22 dicembre, nuovamente vederlo nel primo punto del Capricorno cessare di scendere sotto l'equatore, fermarsi quasi, per poi riavvicinarsi ad esso. Dalla paura che la stranezza di questo fenomeno dovette produrre negli antichi all'accensione di falò propiziatori, il passo è breve. Solo in un secondo tempo, con l'avvento del Cristianesimo, si ebbe l'accostamento dei fuochi col Natale e con la festa di San Giovanni. Mentre i falò bruciavano i giovani saltavano attraverso le fiamme in segno propiziatorio. Se il salto veniva fatto da una coppia di fidanzati, questi si sposavano entro l'anno. Strana curiosità. Il giorno dopo si potevano vedere delle donne chine sulla cenere dei falò. Cercavano in mezzo ad essa "i cavegli de Sän Giuäni" (I capelli di San Giovanni). Sembra, infatti, che nei residui dei falò fossero presenti dei capelli bianchi i quali avevano il potere di guarire le malattie e di portar fortuna a chi li trovava. Oltre alla tradizione del fuoco esisteva pure a Isola la tradizione dell'acqua. Durante la notte di San Giovanni, mentre dappertutto ardevano falò, gruppi di giovani, per lo più ragazzi muniti di secchi e di schite (specie di siringhe di legno che servivano per spruzzar acqua - in tempi più vicini a noi si usarono pure pompe da bicicletta) si divertivano a bagnare passanti. L'unione delle due tradizioni - acqua e fuoco - proprio sul principio dell'estate, stava a simboleggiare nella mente del popolo la fertilità e la fecondità della terra e della natura data appunto da questi due elementi. Anche nella festività di San Luigi si solevano accendere piccoli falò, ma la caratteristica della festa era data dagli scoppi di mortaretti, i cosiddetti mäsculi e delle "bombette di San Luigi". I primi, che, durante i Vespri, al momento del Magnificat, erano fatti scoppiare lontano dalla gente, a causa della loro pericolosità, consistevano in tubi di metallo della lunghezza di 15/20 centimetri e del diametro di 8 cm., chiusi ad una estremità. Lungo il tubo, a poca distanza dalla parte chiusa, v'era il focone in cui veniva inserita una miccia. L'interno veniva riempito per metà con polvere da sparo e l'altra metà era otturata da stracci e da terra impastata e pressata. Accesa la miccia il risultato era prevedibile. Le "bombette di San Luigi", chiamate anche scurifemera, erano dei mäsculi in miniatura. Al posto del tubo di ferro ve n'era uno di cartone, ricavato da una cartuccia da fucile usata, a cui era stato tolto il cilindretto metallico contenente l'innesco. Prima di chiuderlo, da ambo le parti, il cilindretto veniva riempito di polvere nera. A metà cilindro veniva praticato un minuscolo foro per introdurvi un pezzo di miccia a lenta combustione. Il tutto era legato con spago. Una volta acceso, veniva lanciato tra le gambe dei passanti e dei fedeli che uscivano dalla chiesa dopo le funzioni religiose. A tutte le feste partecipavano i rappresentanti della Confraternita religiosa che aveva la sua sede nell'Oratorio di Santa Croce, adiacente alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena e i priori e le prioresse nominati dal parroco durante la messa del primo giorno dell'anno. Tali istituzioni hanno una origine assai remota. Nilo Calvini scrive "E' difficile stabilire l'epoca cui risalgono i movimenti religiosi che hanno dato origine alle numerose Confraternite esistenti nei nostri paesi. Due furono i principali: uno proveniente da Perugia nel 1260 che si estese rapidamente di città in città, specialmente verso nord, arrivando anche a Genova; l'altro, che risale al 1399, partito dalla Provenza, si diffuse anche nella Liguria occidentale. E' probabile che a questa seconda ondata di entusiasmo religioso si debba la ferma volontà di fondare in ogni nostro paese le Confraternite". Nelle Confraternite confluivano i facoltosi del paese i quali dovevano fornire un contributo in vino, olio, grano, avena, castagne che serviva per allestire i banchetti per i poveri che avevano luogo durante la festa di Pentecoste e ai primi di Agosto. Vestigia di tali usi ormai perduti si potevano riscontrare ancora qualche tempo fa quando minestre di legumi venivano pubblicamente cotte per le strade e consumate dai poveri: tali minestre erano chiamate grijöi. Nel dopoguerra è pure lentamente scomparsa una gerarchia presente in seno alla chiesa che vedeva la presenza di Priori (che duravano in carica un anno); Sottopriori (che sarebbero diventati Priori l'anno successivo); Massari; Prioresse; Sottoprioresse. La carica di Priore era assai ambita nella comunità, nonostante comportasse oneri e spese. Il manoscritto Cane è a tal proposito assai eloquente. Riporta in più pagine le attività di un priore e le sue mansioni. L'autore ricoprì più volte tale carica e in alcune pagine trascrive con precisione le spese da lui sostenute per conto della comunità.
1796. Sono stato nominato Priore della Compagnia del Santissimo Rosario. Entrata di quest'anno Per offerte e collette in tutto lanno sono £. 24.8 per canapo venduto 6.2 per ovi venduti 2.4 ricevuto dal mio antecessore Gianbatista Cane fù Giuseppe 33.0 Per oglio venduto in questo anno cioè Rubi 8 e libre dieci a lire dieci sordi doceci cadun rubo 88.16 ricevuto da debitori della Compagnia 15.0 --------- 169.10
1796. Spesa fata per deta Compagnia Per aver fato sbatere e racolte le olivi e spesa alli deficiei in tuto sono 6.12 Per aver fato lavorar in Giroso una giornata bovi e quatro homini in tutto sono 8.10 Per candele comprate libre sedici a sordi cinquanta quatro caduna libra vale 43.4 per porve libre cinque vale 7.0 per ellemosina al Signor Prevosto Cassin per li aniversari 6.0 per tella comprata per da far una tovaglia parmi sedici 9.12 per pizzetti 5.0
1797. Per parmi quindeci damasco rosso da far un contra artare a lire tre e sordi dodeci cadun parmo vale 54.0 per pizeto in argento parmi trentasei 12.0 per froda cioè tella parmi quatordeci 3.10 par manifatura al sartor Gio Antonio Cavassa 3.10 per telaro legname e fatura 2.10 rimesso al mio successore Gerolamo Boer 15.0 --------- 165.8
In altri rendiconti sono pure presenti spese per funerali, per acquisto candele, per acquisto libri, per pagamento di prestazioni varie, per riparazioni di infissi o arredi sacri oppure vengono elencate entrate per vendita di olio, di orzo, di grano di fichi o di altro. Da ciò si deduce che i Priori dovevano assistere ad ogni cerimonia religiosa, riscuotere le elemosine, dispensare il cibo ai poveri che lo richiedevano, radunare dopo i Vespri tutta la gerarchia compreso il parroco, il sindaco e le altre autorità per offrir loro loro cibi e bevande come in un'agape fraterna. Le Prioresse avevano gli stessi doveri dei Priori e durante le cerimonie religiose indossavano un vestito blù e un lungo velo bianco. Durante le processioni, che si facevano indifferentemente alla luce del sole o in ore notturne, il paese presentava aspetti spettacolari e pittoreschi dovuti alla conformazione delle strade e ai fondali del paesaggio. La processione era sempre formata da due lunghe file parallele di gente che avanzava, separata l'una dall'altra di uno, due metri. In testa vi erano le figlie di Maria biancovestite, recanti il loro stendardo ricamato; poi la Confraternita preceduta da uomini che portavano croci di legno, il prete e, infine, la popolazione, sempre su due file distanziate. Durante la processione del Corpus Domini ogni casa che dava sulla strada percorsa dalla processione, aveva i muri e le finestre tappezzate di lenzuola bianche o drappi colorati, mentre il terreno veniva ricoperto da una coltre di fiori, in particolar modo di fiori di ginestra, che i partecipanti gettavano a terra. Più suggestive erano le processioni notturne, effettuate in occasione di particolari festività. Durante il loro svolgimento ogni vicolo veniva illuminato da centinaia di luci prodotte da lumi ad olio, lanterne e gusci di lumaca riempiti di olio e muniti di uno stoppino. Poiché le due file dei fedeli tendevano talvolta a restringersi e a confondersi, alcuni chierichetti, aventi sulle spalle un sanrocchino blu ricamato con fili d'argento, muniti di una bicocca, avevano il compito di mantenere l'allineamento. La bicocca" era un bastone lungo due metri circa col quale si spingevano, con delicatezza, i fedeli immersi nella preghiera invitandoli a riallinearsi.
Folklore letterario
Il patrimonio letterario isolese raccolto nel territorio attraverso i ricordi dei più anziani è piuttosto esiguo. Tutto si è perduto nella notte dei tempi e qualsiasi indagine ha dato risultati negativi perché si è trovata di fronte all’oblio in cui sono cadute vecchie fiabe, vecchie leggende e vecchie storie. Il materiale recuperato consiste in una favola, in proverbi, in modi di dire e frasi tipiche, in qualche ninna-nanna e filastrocca di bimbi , in qualche poesia e canto popolare. La favola U luvu e a vurpe mi è stata raccontata da una vecchietta. I personaggi derivano dall’ambiente esopiano e di esso mantengono le caratteristiche e l’elemento morale. La favoletta non è altro che la spiegazione di un modo di dire locale “Are,äre pe u cian che u maroutu u porta u sän” e cioè il trionfo dell’astuzia sulla dabbenaggine.
FAVOLA U luvu e a vurpe Una vouta u gh’eira a l’ Isura üna vurpe ch’a l’avia recevüu ün tortu da ün luvu de Vrigää; e scicume a ghe brüjia un poucu, a l’ä sercau ün modu pe färghelä pagää. Un balu di a l’a andää a truvää u luvu e a g’ä ditu: - Cumpää, a äi descrüviu ün fundu de fräti lundu g’a de ögni ban de Diu e se ti n’äi cuvea staseia a s’andemu a ence a bustüfäirä. U luvu, che da chela aureglia u ghe sentia, u l’ä acetau. Cändu u s’a fäitu buru, i se sun atruväi tüti dui denai u cunvantu di fräti e da ün sgärbu i sun enträi en t’ün fundu. U luvu u l’a arestau meju babulu cändu u l’ä visto luche gheira. En t’ün cantun üna pila de tumete cun de giäre de brusu, ent’ün autru da sausisa e di salämi, di bighi de stucafissi e arenghi; u gh’eira pöi dui boreghi de mèè ch’i averia resüscitau i morti, e tänte autre couse. U luvu, sansa pensärghe due voute, u l’ä cumensau a mangiää mentre a vurpe a mangìa poucu e ögni tänto a se n’andeija föra pasandu dau sgärbu, pöi a turnia a vegnii. Cändu a vurpe a s’a acorta che u luvu u l’eira cen cume un porcu e rundu cume üna bute e che u nu seria ciü pasau dau sgärbu, fasandu mena de ran a l’ä fau arebatää di stüci chi än fau un fracässu de la Madona. I fräti alauu i sun ariväi cun di bastui e i än cumensau a menää bote da orbi. A vurpe che a l’eira ciü stranscia a l’a sübitu scapä dau sgärbu, mä u luvu c’u nu puria ciü pasää tänto u l’eira ensciu u te n’ä pigliau üna rusta ch’a l’ä lasciau megiu strusciau e mortu. Cändu u l’a revegnüu u l’ä vistu veijin a elu a vurpe ch’a faijia mena de asse ancuu svegnüa. Apena a s’a arevegliä a l’ä cumensau a laumentärse pe e bote ch’a l’avia pigliau e a dii ch’a nu puria ciü caminää. U luvu alauu u se l’ä caregä sciü e späle e u l’ä cumensau a andää. E mentre u caminia a vurpe de sciü e späle a cantia: - Are, äre pe u ciän che u maroutu u porta u sän, - Luche ti di? - A digu che a äi una see ch’a nu ne pösciu ciü e se ti me däi a mentu andemu a beve en t’ün pusu che mi a saciu. U luvu ch’u l’avia ascì see u l’a ditu de scì. I sun cuscì ariväi dau pusu che però u l’avia pouca äigä. A vurpe alauu a l’ä ditu: - Pe beve a faremu cuscì: prima a läpu mi e tu ti me tegni pe a cua. Pöi ti läpi tu e a te tegnu mi. - E cuscì i än fau. Ma cändu u la stau a vouta du luvu, a vurpe, ch’a u tegnia pe a cua a l’ä ditu: - Cumpää, ti me l’äi fä üna vouta mä auu läpä che mi da cua a te läsciu. E cuscì a l’ä fau lasciandu anegää u poveru luvu entu pusu. Murale: Chi a fä, l’aspeite.
“Il lupo e la volpe C’era una volta a Isolabona una volpe che aveva ricevuto un grosso torto da un lupo di Apricale e siccome era rimasta assai scottata, pensava di vendicarsi. Un bel giorno andò a trovare il lupo e gli disse: - Compare, ho scoperto una cantina di frati piena di ogni ben di Dio e se tu ci stai, stasera andremo a riempirci la pancia. Il lupo, che da quell’orecchio ci sentiva benissimo, accettò. Al calar della sera si trovarono tutti e due di fronte al convento e da un buco penetrarono in cantina. Il lupo rimase mezzo sbalordito quando vide tutto quello che conteneva. In un angolo un mucchio di formaggio pecorino con due giare piene di ricotta fermentata; in un altro mucchi di salsicce e salami e inoltre due recipienti di legno pieni di miele che avrebbe resuscitato un morto e molte altre cose. Il lupo senza pensarci due volte cominciò a divorare, mentre al contrario la volpe mangiava poco e ogni tanto usciva passando dal buco per poi ritornare indietro. Quando la volpe si accorse che il lupo era sazio come un porco e rotondo come una botte e che non avrebbe più potuto passare attraverso il buco, facendo finta di niente, fece cadere alcuni barattoli che produssero un gran rumore. Arrivarono allora i frati con bastoni e cominciarono a menar botte da orbi. La volpe che aveva mangiato poco riuscì a scappare subito dal buco mentre il lupo che non poteva passare tanto era gonfio si prese tante bastonate da lasciarlo mezzo rotto e mezzo morto. Quando rinvenne vide vicino a lui la volpe che faceva finta di essere ancora svenuta. Appena questa aprì gli occhi, incominciò a lamentarsi per le botte prese e a dire che non poteva più camminare. Il lupo allora se la caricò sulle spalle e cominciò ad avviarsi. E mentre trotterellava, la volpe sulle spalle canterellava: - Arri, arri per il piano, l’ammalato porta il sano. - Che stai dicendo? - chiedeva il lupo. - Dico che ho una sete tale da non poterne più e se tu mi dai ascolto andiamo a bere in un pozzo che io conosco. Il lupo, che aveva anche lui sete, acconsentì. Arrivarono al pozzo nel quale c’era poca acqua. La volpe allora disse: - Per bere faremo così: prima bevo io e tu mi tieni per la coda; poi bevi tu e ti terrò io. - E così fecero. Ma quando fu il turno del lupo, la volpe che lo teneva per la coda disse: - Compare, me l’hai fatta una volta, quindi ora bevi, bevi e intanto io ti mollo. E così fece, lasciando annegare il povero lupo nel pozzo. Morale: Chi la fa, l’aspetti.
NINNE NANNE
Le ninne. nanne riportate non sono prerogativa della sola Isolabona, ma, con qualche variante, erano diffuse in tutta la valle. Oggi il potere soporifico è affidato dalle mamme ad altri mezzi.
Fä a nänäa pupun de Zena Donda, dundina, Santa Catarina che ta mä a vä en bütega San Peiru e San Faustin e te pä u vende u vin, fäi durmii stu bambin. fä a nänä pupun pecin Stu bambin u nu vöö durmii perché u l’ä pauu de muirii.
Fa la nanna, bambolotto di Genova Donda, dondina, Santa Caterina tua madre se ne va in bottega San Pietro e San Faustino tuo padre va a vendere il vino fate dormire questo piccino. fa la nanna, bambolotto piccino Questo piccino non vuol dormire perché ha paura di morire.
Nanna [nome del bambino]/respondi a chi te ciämä, U te ciamerä u Segnuu /che ti väghi fin d’auu. A m’aissu, a me vestu, /A cäru giù dau leitu a vägu deree l’autää /e a me metu a strumbetää. U cärä u prave pecin /u me dä un gotu de vin, u cärä u prave megiän /u me dä üna feta de pän, u cärä u präve grosu /u me da üna bastunä sciü l’ossu.
Dormi [nome del piccino] /rispondi a chi ti chiama il Signore ti chiamerà. /e affrettati subito. Mi alzo, mi vesto, /scendo dal letto vado dietro l’altare, /e mi metto a strombettare Arriva il prete piccino, /e mi da un bicchiere di vino, arriva il prete mezzano, /e mi da una fetta di pane arriva il prete grosso. /e mi da una bastonata sull’osso
Fä a nänä pupun de pessa /che ta mä a l’a andä a Messa te päire u vegnirà /e ün pupun u te purterä.
Fa la nanna bambino di stracci / perché tua madre è andata a Messa tuo padre verrà / e una bambolotto ti porterà.
FILASTROCCHE
(Alla vista di un gufo i bambini erano soliti dire) Aujagäto, cändu a te vegu a me ne scäpu Gufo, quando ti vedo scappo ögli griji, pän mufiu occhi grigi, pan muffito cändu a te vegu a me ne riu. quando ti vedo me la rido
Sauta pilautu Salta più in alto a Madona a me piglia en brässu la Madonna mi piglia in braccio a me dä ün cügliää de risu mi da una cucchiaiata di riso e a me porta en Paradisu. e mi porta in Paradiso.
.
(I bambini, tenendo in mano una coccinella e spingendola verso la punta delle dita, erano soliti recitare:) Gaglineta du Segnuu Coccinella del signore vätené pe u camin d’amuu vattene sul cammin d’amore cändu ti ariveräi sciü chela cola quando arriverai su quella collina vola, vola,vola, vola. vola via.
Ciöve, spurghina, Piove, pioviggina i gäti i vän enta marina i gatti vanno alla marina Catin a ghe vä deree Caterina va loro dietro e a se ne porta ün balu panèè. e ne raccoglie un bel cesto.
.
Angera, tant’Angera Angela, zia Angela [oppure: Ciancegura Barlegura] o (Ciancegura Barlegura) a pastia i tagliarin impastava le tagliatelle e i eira tänto longhi ed era tanto lunghe da Nisa enfia a Turin. da Nizza sino a Torino.
Angera, tant’Angera Angela, zia Angela a pasia sciü beää, passava sul bordo del canale a l’avia a camija cürta aveva la camicia corta e a mustria l’arimää. e mostrava “l’animale” (le pudende)
Ciüca perà u l’ä fau i fresciöi Zucca Pelata ha fatto le frittelle e u n’ä dau ai sei figliöi. ma non ne ha dato ai suoi figli. I sei figliöi i än fau a fritä I suoi figli han fatto la frittata Mä i nu n’än dau a Ciüca perà. ma non ne han dato a Zucca Pelata.
Padre nostru che t’ei en ti celi Padre nostro che sei nei cieli fighe giänche e canestreli, fichi bianchi e canestrelli i aujieli e fän ci pìu gli uccelli fan cipìu u Pater nostru u l’ä finiu. il Pater nostro è finito.
A bala a se fä i rissi La bella si fa i ricci cun u mänegu da cässä, col manico del mestolo ciümpoucu a se g’amässä per poco non s’ammazza sciù bordu du barcun. sul bordo del balcone. Tralala, pum pum Tralala, pum, pum vä a cantää sciù trävu du Busciun. va a cantare sul trave del Boscione.
A lanterna de Zena La lanterna di Genova . a la fä a trei pissi è fatta con tre pizzi Rusina cui rissi Rosina con i ricci lascemura pasää. lasciamola passare.
Pater nostru da rumänä Pater Nostro della romana chi u cäntä e chi u l’ämä. chi lo canta e chi l’ama. Sän Martin u vä en cielu San Martino va in cielo a pregärne l’Evangelu. per recitare il Vangelo. L’Evangelu corpu sänto. Il Vangelo corpo santo. Corpu Säntu bon giagiün Corpo Santo buon digiuno Bon giagiün che ti faräi Buon digiuno che farai Paradisu ti averäi in Paradiso finirai. Paradisu bona cosa Il Paradiso è un buon posto chi ghe vä se g’arepousa Chi ci va si riposa. A l’enfarnu marie giante All’inferno brutta gente chi ghe vä se ne pante. chi ci va se ne pente.
POESIE
In questa parte sono trascritte poesie d’ogni genere raccolte dalla viva voce degli isolesi e alcune tratte dall’Antologia A Barma Grande. Si tratta di brevi componimenti talvolta di dubbio gusto e di dubbio significato o di poco senso, tramandate di generazione in generazione le quali, se per noi hanno oggi perso qualsiasi significato logico, probabilmente un tempo dovevano muovere il riso di chi le ascoltava.
I l’än mese en t’ün cavägno Tre lire e cätru soudi pe andärle a semenää. e sun tre lire e megia. I credia che fusse fäve U mère de Mentun mä eiran bäle da giugää u l’ä una fea veglia.
Le han messe in una cesta Tre lire e quattro soldi per andarle a seminare son tre lire e mezza. Credevano che fossero fave Il sindaco di Mentone ma eran palle per giocare. ha una pecora vecchia
Vä a cagää e däghe de päte U gheira ün omu en t’ün curegliu Dighe a ta mä che sun fugässe. cu se pichia u cüü cun ün cavegliu. Vä a cagää, däghe di pugni, e di a ta mä che i sun sempugni.
Va a cagare e dalle degli schiaffi C’era un uomo in un corridoio e di’ a tua madre che son focacce. che si batteva il sedere con un capello. Va a cagare e dalle dei pugni e di a tua madre che è un cespo di insalata.
Vrigarenchi da sigärä Apricalesi della cicala ( loquaci) tüti i di i munta e i cärä ogni giorno salgono e scendono i mete i pei en t’a Madona entrano nella chiesa della Madonna tüta a nöite u trona, u trona. e per tutta la notte tuona e tuona.
Carlevää u l’a mortu Carlevää u l’a mortu, envriägu cume ün porcu, u l’a grossu cume un porcu, u l’ä fau u testamentu u l’avia säte figliöi, sciü a porta du cunventu, macarui e raviöi. lasciandu ai sei figliöi Carlevää nu te ne andää tagliarin e raviöi. a te daremu da mangiää da mangiää e da durmii, Carlevää turna a vegnii.
Carnevale è morto Carnevale è morto ubriaco come un porco è grosso come un porco ha fatto testamento aveva sette figli, sulla porta del convento maccheroni e ravioli. lasciando ai suoi figlioli Carnevale non andar via tagliatelle e ravioli. ti daremo da mangiare. da mangiare e da dormire, Carneval torna e venire.
Proverbi e modi di dire
Dopo vari esempi di forme narrativo-popolare è il momento di passare a quella letteratura spicciola a testo fisso che comprende i proverbi e i modi di dire. Di proverbi e modi di dire ve ne sono moltissimi ma, in pieno accordo con Alberto Cane il quale si è occupato in questa monografia di tutta la parte dialettale, si è deciso di restringere il campo a quelli più caratteristici e curiosi, tralasciando, invece, quelli che altro non sono se non la traduzione dialettale di proverbi italiani. Una parte di essi si presenta sotto forma di massima; un’altra parte, invece, sotto forma poetica. Non è qui il caso di vedere se esiste una corrispondenza tra le varie rime in quanto, spesso, si trattava di assonanze. I proverbi più diffusi sono quelli concernenti aspetti di vita pratica o aspetti agricoli e in essi il buon senso e l’esperienza si sostituiscono alla scienza e alla filosofia. Circa l’aspetto esteriore hanno una forma breve che contiene in sé la doppia possibilità, quella di essere facilmente ricordati e quella di poter essere agevolmente tramandati a generazioni future appunto per la forma sintetica e per la loro semplicità che può adeguarsi ad ogni mente. Per comodità del lettore che ha poca familiarità col dialetto, ogni proverbio o modo di dire sarà seguito dalla traduzione o da un commento esplicativo.
Proverbi moraleggianti
A forsa d’andää a l’äigä cun ün brocu u se ghe rumpe u mänegu (Continuando ad attingere acqua con la brocca, finisce per rompersi il manico) A marda ciü i a remes-cia e ciü a spüsa (La merda più si rimescola più puzza) A vurpe a nu fä levre (La volpe non genera lepre) Ae giante de marina enceighe a män e gireighe a schina (Alla gente di mare riempite loro la mano, ma voltatele la schiena) Ai Sänti vegli nu g’asande ciü de candere (A santi vecchi [passati di moda] non accendere più candele) Andää a vee e sciure daa pärte de raije (Andare a vedere i fiori dalla parte delle radici. Morire. Basta ün suru luvu a fää scapää santu fé (Basta un solo lupo a far scappare cento pecore) Baujairu cunusciüu, u nu l’a ciü credüu (Bugiardo conosciuto non viene più creduto) Besögna pigliää u mundu cume u van (Bisogna prendere il mondo come viene) Caciaüü e lumasèè i porta e strässe denai e derèè ( Cacciatori e cercatori di lumache portano toppe davanti e di dietro) Cändu a vidua a se maria a penitansa a nu l’a ancuu finia (Quando la vedova si risposa la penitenza non è ancoea finira) Cändu u figu u s-ciopa , l’anghila a toca (Quando il fico matura, l’anguilla è pronta per essere catturata) Cändu turta e cändu grili (Quando torta e quando grilli) Cändu u poveru u fä u pän u se deroca u furnu (Quando il povero riesce a fare il pane il forno si sfascia) Cändu u tampu u l’a en burräscä u van da dii u Credu (Quando il tempo è brutto, si è portati a recitare il Credo) Cärne c’a se striglia a nu va üna caniglia, ma cändu a l’a strigliä a nu se pöö pagää (Persona che si stiracchia non vale un frutto marcio, ma una volta stiracchiata non si puo pagare) Cärne ch’ a cresce a bugia (Carne che cresce è vivace. Detto di bambini assai vivaci) Chi ciü n’ä ciü ne vuria (Chi più ne ha più ne vorrebbe) Chi dorme cun ün cän u s’areveglia cun e purije ( Chi dorme con un cane si sveglia con le pulci) Chi en giuventüra ciänta, en veciäirä cänta ( Chi semina da giovane, raccoglie da vecchio) Chi gägnä de prima män u se ne vä cun e bräghe e män (Chi vince di prima mano se ne va spogliato) Chi maneggia, lecheggia (Chi maneggia soldi può soddifare i piaceri) Chi nu ä üna cruije u l’ä üna cruijäsä e se u nu a pöö purtää u a stiräsä (Chi non ha una croce piccola ne ha una grande e se non può prtarla la trascina) Chi nu ne ä u se nega (Chi non posiede nulla, affoga) Chi nu n’ä u nu n’asgäirä (Chi non ne ha non ne sciupa) Chi nu s’encälä nu se sciälä (Chi non osa non gode) Chi rie de bon matin, ciägne de seira (Chi al mattino ride, piange la sera) Chi se maria föra de cä u fä ustaria e u nu u sä (Chi si sposa fuori del paese, fa di casa sua un’osteria e non lo sa) Chi serca rugna u saa grätä (Chi cerca guai se li gratti) Chi spande e u nu ne mette u l’arasta cun e mäe nete (Chi spende e non guadagna, rimane a mani nude) Chi u nu dä a mentu au päire e a mäire en arba, sciü i gareti u ghe cärä a marda (Chi da piccolo non ascolta i genitori, da grande se la farà nei calzoni) Chi vä au boscu pärde u postu (Chi va al bosco perde il posto) Chi vive sperandu möie cagando (Chi vive sperando muore disperato) Cun ran u nu se fä ran (Con niente non si fa nulla) De andää descausi e de lavurää ban fundu u nu s’a mäi arichiu nesciün au mundu (Andare scalzi e scavar fondo non si è mai arricchito nessuno) Dopu u riäsu u van u ciagnäsu (Dopo il ridere viene il pianto) E fee ciorneghe e se mängiä u semenau (Le pecore miopi distruggono il seminato) Entu mundu chi nu nöa vä a fundu (Nella vita chi non sa nuotare, affonda) Fari da tägliu, done e müra, beätu chi gh’enduvina (Ferri da taglio, donne e mulo, beato chi ci azzecca) Finché u ghe n’a aviva Giausà, cändu u nu ghe n’a ciü aviva Gesù (Finché ce n’è evviva Giuseppe, quando non ce n’è più evviva Gesù) Grämu l’änse che u nu sää purtää u sè bästu (Gramo l’asino che non sa portare il suo basto) I brävi e i giüsti i än e scärpe de vedru (I bravi e i giusti han le scarpe di vetro) L’änse dunde u s’arebätä üna vouta u nu s’arebätä ciü (L’asino non casca due volte nello stesso posto) Lunde u g’a ciü pässi che bucui, läsciäghe andää i cugliui (Dove c’è più da cmminare che da mangiare, lanscia andare i coglioni) Mangiää e gratää u basta cumensää (A mangiare a a grattarsi, basta incominciare) Ne a tortu ne a reijun nu te fää mete en preijun (Ne a torto ne a ragione non ti far mettere in prigione) Strentu au brenu, lärgu aa farina (Avaro con la crsusca, prodigo con la farina) Tütu u van au tägliu cume e unge pe perää l’agliu (Tutto viene al pettine come le unghie per pelare l’aglio) U ban u stä sampre suvre cume l’öriu (Il bene sta sempre a galla come l’olio) U ciöve sampre sciù bagnau (Piove sempre sul bagnato) U fä fää u se porta u fau (Il continuare a costruire si mangia il costruito) U l’a ciü bon u vin du rugliu che chelu da räpä (E’meglio il vino della botte che quello dei raspi) U l’a sampre megliu lecää che morde una vouta sura ( E’ sempre meglio leccare che mordere una sola volta) U se vä aa fin de tütu (Ogni cosa ha la sua fine) U tampu bon u nu pöö durää, u brütu mäncu (Il tempo buono non può durare, il cattivo nemmeno) Una vouta perün en bräsu aa mämä (Una volta per ciascuno in braccio alla mamma)
PROVERBI DELLA CAMPAGNA
A Sän Michèè u ciöve chinse di avanti o chinse di derèè (A San Michele piove o quindici giorni prima o quindici dopo) A Säntä Catarina u freidu u s’aveijina (A Santa Caterina si avvicina il freddo Aigä tria a bägnä e a nu bäte a cria (Pioggia fine bagna senza far rumore) Cändu e nivure e fän u pän se u nu ciöve ancöi u ciöve deman (Quando le nubi sono a pecorelle, se non piove oggi piove domani) Cändu i foi i se mete a ruscegää, meteive a semenää (Quando i larici ri mettono a rosseggiare, mettetevi a seminare) Cändu Tauräge u l’ä u capelu u tampu u l’a bälu. Cändu Taurage u l’ä a centüra un tampu u nu düra (Quando il Monte Toraggio ha il cappello [di nubi] il tempo è bello. Quando, invece, ha la cintura il tempo non dura) Cändu u cäntä u cücu, aa matin u g’a bagnau e aa seia sciütu (Quando canta il cuculo al mattino il terreno è bagnato e alla sera asciutto) Cändu u cäntä u tron avanti u cücu a l’a üna bona anä de tütu (Quando si sente il tuono prima di sentire il canto del cuculo, è una buona annata per tutto) Da Säntä Caterina a Deneää u g’a un balu mesu engää (Da S.Caterina a Natale c’è ancora un mese) Dopu trei di de nage o äiga o vantu (Dopo tre giorni di nebbia o acqua o vento) Fin a Sänt’Anä i faijiöi i munta sciü a cana. Da Sänt’Anä en sciü i nu munta ciü (Fino a SantAnna i fagioli cresco e dopo non più) Fin a Sän Sebastiän u se semena u grän. De Sän Sebastiän en là u se semena luche i än (Fino a San Sebastiano si semina il grano. Da S. Sebastiano in poi semina quel che ai. Una giurnä d’äigä de magiu a vä tant’ouru (Un giorno di pioggia a maggio vale tanto oro) Su ciöve cändu u suu u l’a en Leun e aurive e cärä sansa bastun (Se il sole è nella costellazione del Leone le ulive cadono senza abbacchiarle) Su ciöve u di da Cruije, pouche castägne e tänte nuije (Se piove il giorno di Santa Croce, poche castagne e molte noci) Vä ciü ün rugliu che santu spurghinäe (Val più una pioggia abbondante che cento pioggerelline)
Modi di dire e frasi tipiche
A dirla s-cetta (Per dirla chiaramente) A l’a cume a foura du bestantu (Detto di cose di cui non si viene mai a capo) A n’äi üna fura (Non ne posso più) A nu m’encälu (Non oso) A sun sciäiru e stransciu (Sono fiacco e magro) A vä andandu (Tiriamo innanzi alla bell’e meglio) Andää a dää mangiää au pürije (Andare a dar da mangiare alle pulci. Fare lavori inutili) Andää a tirää (Andare alla visita di leva) Andää de cansää (Camminare in malo modo. Camminare di sghembo) Andärse en peti e menieti (Andarsene in brodo di giuggiole) Andärsene a l’amüsu (Andarsene a muso lungo???) Ase aa coca (Essere allo stremo) ???? Ase cume ün pin bugiu (Essere come una pigna verde) Ase en chicura (Essere in forma) Aseghe de bon fää (dicesi di terreno facile a coltivarsi) Au tampu di ruländi i pecìn i cumända i grändi (Dopo la vedemmia sono i più piccoli a comandare) Avèè e grunde caräe (Essere aggrondati) Avèè u muru brütu cume u cüü da paala (Avere la faccia sporca come il fondo della padella) Avèè u pisciu ägru (Aver la luna storta) Averlu in tu stupin (Essere fregato) Averne ün tocu pe cheicüun (Aver a che ridire su qualcuno) Balu bardotu (Bel garzone) Beijärse u gumeu (Baciarsi il gomito. Fare una cosa impossibile) Cagää sciu una ciapa (Fare i bisogni su una lastra) Candu u ciöve e u g’a u suu e fautüreire e fan l’amuu (Quando piove e c’è il sole le streghe fanno l’amore) Che lavastru! (Che pioggia torrenziale!) Ciü en lä u g’a i Barbeti (Oltre ci sono i Barbeti - spauracchi per bambini) Ciucärghere (Suonargliele) Cruije e biscia (Croce o biscia - Testa o croce) Dää a mentu (Badare, ascoltare) Därghe modu (Dare la possibilità) Därghere tüte vinte (Dargliele vinte tutte) De bona mena (Di buona maniera) Düru cume un becu (Duro come un caprone) En cega ögli (A occhi chiusi) En con du diu (Alla fine del giorno) Fää e bruchete (Fare le bullette) Fää ün sgärbu a bägnu (Fare un buco nell’acqua) Giugää ae longhe (Giocare alla lunga nel gioco delle bocce) I bruti i sun taneri (I rami d’ulivo sono teneri detto di uno che sta per ribellarsi o esplodere) Lambicärse u servelu (Spremersi le meningi) Lége a vita (Leggere la vita) Levää dau semenau (Togliere dal seminato. Togliere dagli impicci) Levärse d’en t’ün sbregu (Togliersi da un pasticcio) Luche ti bumbuni? (Che cosa borbotti?) Luche ti cifugni ? (Che cosa traffichi?) Luciää en tu mänegu (Vacillare nel manico) Mägru cume ün picu (Magro come un piccone) Mäie i me piglia- läsciäte pigliää- mäie e me cöije- läsciäte cöije- mäie i me mängiä-läsciäte mangiää- mäie i me veve- läsciäte beve u vin adosu - figlia ti ei parsa. (Madre mi pigliano, lasciati prendere; madre mi cuociono, lasciati cuocere; madre mi mangiano, lasciati mangiare; madre mi bevono il vino adosso. Allora, figlia mia, sei persa. Tutto ciò detto nel senso di tollerare fino ad un certo punto e non oltre. Mätu cume ün curbin (Matto come una cesta da uva, nel senso: essere fuori di testa o ubriaco) Mes-ciärse u belin cun un servelu (Andar fuori di testa) Nu m’ensciää a teta (Non gonfiarmi la tetta nel senso di: lasciami in pace) Nu me fää muntää u sacramentatätu (Non farmi andare in bestia) Oh, mi povera bagäscia! (Oh, me povera sgualdrina! Espressione usata da tutte le donne che ormai l’hanno adottata come esclamazione quando voglio esprimere stupore) Parää u säcu (Tener aperto il sacco) Pescauu de cänä, caciauu de viscu, purtauu de Cristu i sun i tre ciü belinui che g’a sciü sta tara (Pescatore con la canna, cacciatore con il vischio e portatore di Cristo, durante le processioni, sono i tre più stupidi di questa terra) Picärghe du muru (Sbatterci con la faccia) Pigliärserä düra (Prendersela a cuore) Revirärse cume un cän (Rivoltarsi come un cane) Sa nu l’a vera a l’a bärca (Se non è vela è barca nel senso di Se non è così è il contrario) Sarne en tu mäsu (Scegliere nel mazzo) Sbäte l’äigä (Sbattere l’acqua) Sciavasärsene e bäle (Sbattersene allegramente le palle) Sciütu cume l’esca (Asciutto come un’esca) Stärsene ciuri (Stare rannicchiati al caldo.) Ti ei apenisau cume ün rebisu (Te ne stai rattrappito come uno scricciolo) Ti ei üna bala basara (Sei una bella intrufolona) Tirää i gambin (Tirare le cuoia) Ti s-ciupessi! (Ti venisse un colpo!) U cärä i beiocchi (Dicesi di bimbo che sta per addormentarsi) U l’a bon cume u pän ma ciü longu du Säbu Säntu (Buono come il pane ma lungo come il Sabato Santo) U l’a cübu (E’ buio) U l’a mätu cume ün cavägnu, stüpidu cume üna crävä e grämu cume u töscegu (E’ matto come un cestino, stupido come una capra e gramo come il tossico) U l’a megliu un änse sansa pee che a canderäiä cun u surèè (E’ meglio un asino senza pelo che una ???? con il solaio) U l’a un balu vee (E’ una bella vista) U l’a ün peugliu revegnüu (E’ un pidocchio rinato. Si dice di un miserabile arricchito) U m’a carau en te unge di pei (Mi è sceso sin nelle unghie dei piedi. L’ho gradito moltissimo) U nu gh’eia ärimä viva (Non c’era proprio nessuno) U nu sä mäncu fää üna O cun ün canun de cänä (Non sa fare una O neppure con un cilindro di canna) Un beelin che te neghe (Un pene che ti strozzi nel senso di:Un accidenti che ti colga) Vä a cagää en ta sene (Va’ a defecare nella cenere) Vègliu cume u cüucu (Vecchio come il cuculo) Vöu cume S.Paulin (Vuoto come S. Paolino)
Conclusione
Più che concludere con considerazioni legate al solo paese di Isolabona, si ritiene più opportuno analizzare l'intera vallata. Le tradizioni pervenuteci dal passato hanno tentato, come edera sempre viva, di aggrapparsi all'humus fertile della memoria per poter continuare a vivere. E' noto però che la sopravvivenza di motivi folkloristici tende a resistere in località che, per la loro natura geografica (isolamento o lontananza dalle grandi vie di comunicazione) hanno più possibilità di custodirli, mentre questi motivi tendono rapidamente a scomparire nelle località "più esposte al contatto con l'esterno". In Val Nervia le tradizioni hanno resistito fino a quando l'uomo ha trovato possibilità di sopravvivenza; ma quando è stato costretto a cercar lavoro oltre le mura del paese e ad abbandonare per lunghi periodi o per sempre il focolare, anche le tradizioni sono lentamente sbiadite e hanno perduto le loro radici. L'insieme delle tradizioni recuperate sul filo della memoria ci permette, comunque, di definire il carattere generale degli isolesi, che poco si discosta dal carattere generale degli abitanti della Val Nervia. L'isolese è in linea di massima persona osservante dei precetti morali; grata ai benefici ricevuti e di rado facile a dimenticarli; attaccata al lavoro e alla terra; fiera e inesorabile con chi gli vuol nuocere; intraprendente e al tempo stesso circospetta; non si lascia facilmente abbattere dagli ostacoli ma cerca sempre di vincerli; fissa ad una meta qualora intraveda un facile guadagno, ma pronta ad abbandonare quando il danno gli si profili.
Prefazione | PARTE I | PARTE II | PARTE III | PARTE IV
|